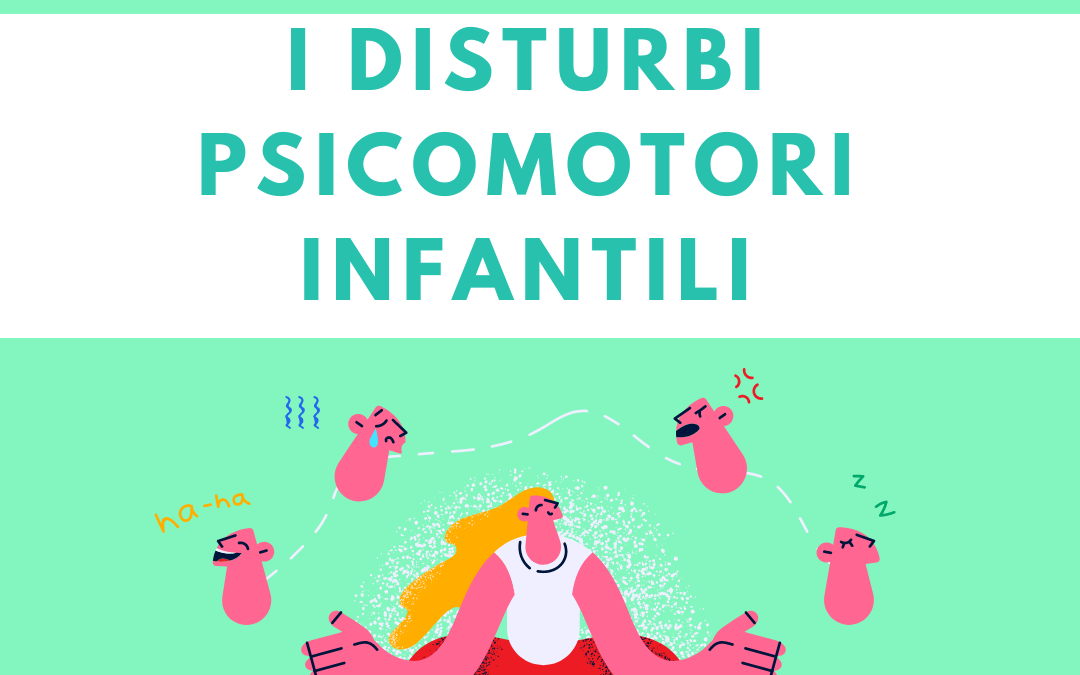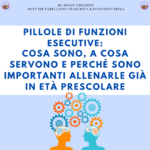
PILLOLE DI FUNZIONI ESECUTIVE: cosa sono, a cosa servono e perché sono importanti allenarle già in età prescolare
Dicembre 8, 2020
I PRINCIPALI SENSI ALLA BASE DELLO SVILUPPO NEUROPSICOMOTORIO DEL BAMBINO
Dicembre 17, 2020Nell’insorgenza dei disturbi PSICOMOTORI infantili si ipotizzano diverse cause: nascita pretermine, fattori ereditari o chimici, asfissia alla nascita o mancato / anomalo sviluppo dell’integrazione dei vari sistemi sensoriali (Ayres), che portano ad una disorganizzazione neurologica, mancato o anomalo sviluppo dei riflessi neonatali o primitivi (Sally Goddard), problemi che derivano da modalità di attaccamento disturbate, insicure o disorganizzate o da angosce infantili (Simonetta)
Elenchiamo i principali disturbi psicomotori che sono oggetto della nostra analisi, valutazione e riabilitazione.
L’inibizione psicomotoria può manifestarsi con:
– rigidità e ipercontrollo
– passività e apatia
– ipertonia e incoordinazione.
Il bambino dimostra una generalizzata mancanza di iniziativa rispetto all’ambiente. Ciò che va sottolineato è che l’inibizione spesso non è solo sul piano motorio ma anche cognitivo e sul piano dell’organizzazione dello Schema Corporeo
Le funzioni psicomotorie disturbate sono la FUNZIONE DI AGGIUSTAMENTO E DI PERCEZIONE.
Gli indici psicomotori più significativi sono le alterazioni della regolazione tonica, del controllo tonico ed emotivo, dell’aggiustamento spontaneo, della coordinazione dinamica globale.
Sembra che il bambino inibito non abbia la percezione di sé e del proprio corpo: questo limita le sue possibilità di interazione ed esplorazione con l’ambiente e la possibilità di attivare quei circuiti sinaptici corticali fondamentali per il suo sviluppo emotivo-sociale-scolastico-intellettivo. Non non riuscendo a riconoscersi, in genere non è capace nemmeno di disegnare se stesso. La conseguenza è un comportamento privo di iniziative, povero, stereotipato e ripetitivo con scarsa capacità di trovare risposte e strategie adeguate alla risoluzione di un compito o al raggiungimento di uno scopo, iper o ipotonicitá, scarsa insistenza nei tentativi per raggiungere l’obiettivo
L’instabilità psicomotoria o sindrome ipercinetica è un disturbo della funzione di AGGIUSTAMENTO spontaneo, che si determina nei primi 3 anni di vita.
Questa instabilità si rivela nell’adulto con stati ansiosi-depressivi e compulsivi o forte labilità emotiva ( Levi-Romani, 2012)
I principali sintomi clinici a livello psicomotorio di questo disturbo sono: notevole difficoltà nell’attivazione dello stato di allerta/ vigilanza mentale (Arousal), nell’orientare l’attenzione e mantenerla per un periodo di tempo prolungato, scarsa attenzione ai particolari (attenzione selettiva deficitaria), scarsa capacità di percezione del proprio corpo e di rivolgere l’attenzione dentro se stesso, notevole ipercinesia con difficoltà nei processi di autocontrollo e conseguente impossibilità di fermare volontariamente le proprie azioni o i propri pensieri, il proprio linguaggio (non controllo della motricità e verbalizzazione), comportamenti spesso impulsivi, provocatori e aggressivi.
L’instabilità si può manifestare con due modalità:
– ipercinesia
– impulsività e disattenzione
Il bambino con instabilità psicomotoria non è aggressivo ma agitato e impulsivo: il suo corpo non gli comunica le sensazioni giuste, ovvero come dovrebbe muoversi nello spazio e come dovrebbe interagire con lo spazio, in modo da rispondere in maniera adattiva alle richieste; piuttosto gli pone dei problemi di controllo e di difficoltà nell’autoregolare la propria attivazione.
Modalità relazionali incoerenti da parte delle figure genitoriali possono ulteriormente peggiorare l’instabilità del bambino.
Lo stato di “non controllo” dei propri impulsi può essere considerato anche come una modalità di espressione delle proprie tensioni interne che il bambino non riesce a gestire e tollerare, o come una perdita di controllo da parte del cervello: la sua eccessiva attività è una reazione compulsiva a sensazioni che non è capace né di evitare né di organizzare, la confusione dentro il suo cervello rende impossibile l’autocontrollo / autoinibizione, l’attenzione e la concentrazione su un determinato compito o attività.
Nel corso dei primi 2 anni di vita presenta una disarmonia nello sviluppo psicomotorio: in particolare si osserva un notevole sviluppo della motricità a sfavore dell’attività percettiva.
A scuola, questa “instabilità psicomotoria” si accompagna a difficoltà nel prestare attenzione all’insegnante o nel terminare un compito, alternanza di prestazioni positive a prestazioni insufficienti, dunque si rileva una discordanza di performance a livello cognitivo.
È inutile dire a questi bambini di controllarsi di più, di stare fermi o di stare più attenti: il problema è nei meccanismi/processi mentali che sono oltre la coscienza, la volontà e il controllo.
Parole, premi e punizioni non aiuteranno il bambino ad organizzare meglio la sua attività cerebrale o le sensazioni che riceve dall’esterno e dal proprio corpo, mentre attività sensori-motorie/ prassiche aiuteranno il cervello di quel bambino ad organizzarsi maggiormente e a rispondere in maniera adeguata e consona alle situazioni e alle sfide che gli si presenteranno nella vita quotidiana, rendendolo inoltre più sicuro e felice.
Senza un intervento terapeutico, tale disordine può essere all’origine di gravi problemi sul piano sociale e divenire un disturbo psichiatrico ancora più serio.
Inannzitutto dobbiamo porre particolare attenzione a distinguere la DISPRASSIA ACQUISITA, dunque un deficit quantitativo, per esempio in seguito ad un danno cerebrale causato da un trauma cranico, DA QUELLA ASSOCIATA AD UN RITARDO O A UN DISFUNZIONAMENTO/ DISORDINE DEL NORMALE SVILUPPO NEUROLOGICO.
Noi, in quanto riabilitatori, prenderemo in considerazione il disordine funzionale di tipo qualitativo.
La disprassia è un disordine funzionale e qualitativo nella ideazione ed esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio diretti ad un determinato scopo, in assenza di deficit organici o deficit sensoriali. Il bambino è lento e inefficiente nella pianificazione motoria (la maggior parte dei bambini affetti disprassia non ha problemi con i movimenti della programmazione centrale, ad es. camminare carponi o camminare eretti, ma con le abilità che richiedono una precisa pianificazione), sebbene abbia una intelligenza nella media e una muscolatura adeguata.
Il disturbo è pervasivo, multifattoriale ed estremamente complesso, non riguarda solo la coordinazione e il movimento ma anche il linguaggio, il pensiero, la cognitività, la simbolizzazione, la memoria, la percezione, l’attenzione, l’autoregolazione, dunque tutte le Funzioni Esecutive umane.
Questi segni e sintomi costituiscono dei campanelli di allarme importanti per poter mettere in atto un intervento tempestivo in tenera età, in modo da far acquisire al bambino una organizzazione prassica adeguata per i futuri apprendimenti scolastici e per un buon comportamento sociale e adattivo.
La definizione stessa di “immaturità psicomotoria” implica un ritardo nella maturazione della motricità in riferimento alla naturale evoluzione delle prassie. Tale ritardo non è attribuibile a lesioni nervose ma a un disordine nella strutturazione della motricità.
Il ritardo psicomotorio può essere sintomo di un deficit della strutturazione funzionale del SNC, che può anche interessare la funzione gnosica, sia a livello prassico che simbolico.
Tutti i bambini con ritardo intellettivo manifestano anche un ritardo più o meno importante nella motricità, mentre alcuni bambini con intelligenza nella media possono presentare problemi isolati a livello della motricità.
Il disturbo di lateralizzazione si manifesta con l’impossibilità del bambino nel riconoscere percettivamente i due emisomi corporei e si presenta quando il soggetto non può basare il processo di lateralità sull’identificazione di una propria prevalenza motoria naturale. In particolare, il disturbo riguarda la mancata lateralizzazione, ovvero la difficoltà di percepire e riconoscere su di sé e verbalizzare la differenza funzionale tra i due lati del corpo.
Si associa frequentemente alla disprassia: molti bambini disprassici non hanno una dominanza laterale ben affermata o definita (Ajuriaguerra, Crispiani, SImonetta, Massenz, Nicolson, Fawcet, ecc.)
Redatto dalla Dott.ssa Francesca Tabellione
Grafica:Dott.ssa Erika D’Antonio