
da admin
BAMBINI GOFFI, DISPRASSICI E BAMBINI IMPACCIATI: STRATEGIE E CONSIGLI PRATICI PER SUPPORTARLI NELLO SVILUPPO
per lavorare con la disprassia e dsa DISPRASSIA – BC BRAIN CHILDREN DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - DSA – BC BRAIN CHILDREN

da admin
BAMBINI GOFFI, DISPRASSICI E BAMBINI IMPACCIATI: STRATEGIE E CONSIGLI PRATICI PER SUPPORTARLI NELLO SVILUPPO
per lavorare con la disprassia e dsa DISPRASSIA – BC BRAIN CHILDREN DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - DSA – BC BRAIN CHILDREN

da admin
COME POSSIAMO FAVORIRE O INCREMENTARE LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO NEL BAMBINO?STRATEGIE E CONSIGLI UTILI
SEMPLICI CONSIGLI E STRATEGIE PER SVILUPPARE O INCREMENTARE IL LINGUAGGIO DEL BAMBINO Iniziamo con una constatazione neurofisiologica e neurobiologica fondamentale: il cervello del bambino è plastico, come diceva la famosa Montessori. Che cosa significa questo? Che il suo cervello in formazione è come una spugna, ovvero assorbe tutto ciò che raccoglie attraverso i sensi, i nostri primi canalizzatori- vista, udito, tatto, gusto, olfatto- sia in positivo che in negativo. La differenza tra il cervello adulto e quello infantile è che il bambino nasce con uno staff di neuroni al completo ma questi neuroni non comunicano tra loro; solo successivamente impareranno a farlo (quando il piccolo compie esperienze sensoriali e motorie) attraverso le sinapsi, che sono collegamenti tramite i quali i neuroni si scambiano le informazioni determinando il costante processo di adattamento all’ambiente circostante. Grazie alle sinapsi e alle interconnessioni di una quantità immensa di informazioni che rendono possibili, la mente riesce a svolgere tutte le sue funzioni cognitive. Questa premessa serve per farvi capire come "immergere" il neonato, già dai primi mesi di vita, in un ambiente altamente stimolante a livello "uditivo" sia molto positivo, un ambiente fatto prima di toni di voce pacati e rilassanti all'occorrenza, poi di parole, e ancora dopo di frasi chiave per esprimere un bisogno o un desiderio, fino al discorso lineare e sintatticamente strutturato. In questo modo ecco che entra in gioco quella che pare una timida ma intrigante "magia" rappresentata dal fatto che, grazie alla neuroplasticità cerebrale, si formerà lo schema linguistico che sarà proprio di quel bambino vissuto in quel dato ambiente. Il bambino già a partire dai 6 mesi comprende il linguaggio dell'adulto, fatto di gesti, sguardi, suoni dolci, espressioni: questo significa che la sua comprensione avviene molto prima della produzione del linguaggio. Dai 6 mesi o poco dopo, inoltre, compare la "lallazione", una serie interminabile di sillabe ripetute (bababababa, lalalalalala) che costituisce la prima forma di comunicazione: il bimbo si sente corrisposto quando ripete queste sillabe e per la prima volta "dialoga" con qualcuno, anche se a suo modo. Sebbene esista una notevole variabilità inter-individuale nello sviluppo del linguaggio, ovvero ogni fanciullo sviluppa il suo linguaggio in tempi e in modi differenti, si possono individuare delle tappe fisiologiche all'interno delle quali ciascun bambino dovrebbe rientrare. Di norma, l'età di comparsa delle prime parole si colloca tra gli 11 e i 13 mesi; successivamente possiamo distinguere due fasi principali: la prima fase é intorno ai 12-16 mesi, caratterizzata da un vocabolario di circa 50 parole. La seconda fase è verso i 17-24 mesi, in cui sviluppa un vocabolario di circa 100 parole fino a comporre vere e proprie frasi con due o più parole verso i 30 mesi (es. "Mamma pappa"). Le prime parole riguardano le sue necessità primarie: "pappa, nanna, ciuccio"; successivamente comincerà a pronunciare anche "mamma, papà, nonna", in particolare quando il fanciullo si accorge che, chiamandoli per nome, i propri caregiver si girano e rispondono alle sue richieste. In poco tempo emerge la cosiddetta "esplosione del vocabolario", in cui ogni oggetto viene etichettato correttamente, soprattutto perché il bebè è entusiasta di "comunicare"! 7 CONSIGLI PRATICI PER LO SVILUPPO LINGUISTICO È scientificamente dimostrato come i genitori e le figure primarie che ruotano attorno al bambino giochino un ruolo fondamentale nell'adottare una serie di sani accorgimenti e nel sostenere il bambino al meglio verso un corretto sviluppo comunicativo, linguistico e cognitivo dal momento che, come abbiamo accennato, il linguaggio è un'abilità che si assorbe e si apprende dall'ambiente circostante. 1. GUARDARE IL BAMBINO NEGLI OCCHI QUANDO SI PARLA: anche se il sistema visivo non è completamente maturo alla nascita, si osserva che i bambini di soli due giorni di vita sono maggiormente attratti verso i volti che li guardano. Dunque è importante guardare il piccolo negli occhi quando giochiamo con lui, quando mangia, quando dice le prime paroline o quando gli parliamo (in modo che possa anche osservare i nostri movimenti oro-bucco-facciali, fondamentali per l'articolazione dei suoni). 2. PARLARE IN MANIERA CHIARA, SEMPLICE MA CORRETTA I genitori devono sempre parlare al bambino utilizzando una terminologia corretta e senza distorcere le parole, a partire dalle prime settimane di vita: anche se il neonato non comprende il significato dei suoni che sente pronunciare, pian piano tali suoni verranno inconsapevolmente interiorizzati e "fatti propri" per produrre in futuro prima le sillabe e poi le parole. Utilizzare pertanto un linguaggio lineare, a ritmo costante (né troppo lento né troppo rapido) e fatto di frasi brevi che descrivano passo dopo passo ciò che fa il bambino, che vede o che sente/prova. 3. FAVORIRE L'USO DEI GESTI: prima di parlare, il bambino piccolo indica per comunicarci ciò che desidera, utilizzando quella che viene chiamata "comunicazione gestuale". I gesti sono dei precursori del linguaggio, servono per pensare e per parlare: vi è quindi una correlazione diretta tra azioni, gesti e produzione linguistica. 4. FAVORIRE LA LETTURA: la lettura condivisa è una delle attività più semplici e preziose che possiamo fare per sostenere l'evoluzione linguistica, comunicativa e cognitiva. Ascoltare una storia, già a partire dai 6 mesi di vita, stimola la comprensione verbale e permette di apprendere le prime parole naturalmente, in modo che quando sarà pronto, il bambino potrà pronunciarle. Il suo cervello è come una spugna quindi, anche parole che leggiamo e che pensiamo possano essere per lui difficili, è bene spiegarle cercando di utilizzarle anche nel quotidiano. 5. FAVORIRE LA CONDIVISIONE DI ESPERIENZE: stimolare il linguaggio anche attraverso le opportunità di relazione e di socializzazione, ad esempio possiamo portare il bambino al parco giochi, all'asilo o allo zoo, creando opportunità per apprendere altri vocaboli e per condividere esperienze ed emozioni nuove. Ad esempio, al rientro dall'asilo, chiediamo al bambino cosa ha fatto a scuola, se ha condiviso qualche gioco con gli amichetti, se ha giocato da solo e cerchiamo di fargli esprimere anche le proprie emozioni (gioia, tristezza, divertimento, paura, rabbia, sorpresa, ecc). 6. EVITARE DI SOSTITUIRCI AL BAMBINO: molto spesso facciamo il grave errore di sapere quello di cui il piccolo ha bisogno. Così facendo non diamo a lui né il modo né il tempo di comunicare e di sviluppare adeguatamente le proprie abilità comunicativo-linguistiche. 7. ESPANDERE LE FRASI ED EVITARE DOMANDE CHIUSE: anziché interrompere e correggere il bambino mentre parla, aspettiamo che finisca la frase e, senza mai dirgli che ha sbagliato, forniamogli il modello corretto e la giusta intonazione. Ad esempio, se dice: "ciuccio sporco", possiamo ampliare la frase dicendo: "si, il tuo ciuccio è caduto a terra e ora è sporco!". Inoltre sarebbe consigliabile evitare le domande chiuse che limitano lo sviluppo del linguaggio, bensì incitare quelle aperte in modo che il bimbo possa parlare il più possibile e sforzarsi nel ricercare e produrre paroline. Quindi, non dobbiamo dire ad esempio "vuoi la carne?" ma "cosa vogliamo mangiare di buono a pranzo?", e soprattutto non dobbiamo mettere fretta al bambino ma dargli qualche secondo per elaborare la domanda e fornire una risposta (se questa risposta non ci sarà, riformuleremo di nuovo la domanda in modo più semplice o con altre parole, assicurandoci che il piccolo ci stia ascoltando e soprattutto guardando negli occhi!). (Articolo a cura della Dott.ssa Francesca Tabellione, tnpee- docente presso enti accreditati, specializzata in neuropedagogia dei processi cognitivi e psicomotricità neurofunzionale, terapista itard)

da Erika
COME POTENZIARE LE FUNZIONI ESECUTIVE IN ETA' PRESCOLARE E SCOLARE IN UN BAMBINO DISPRASSICO
Incrementare o potenziare le Funzioni Esecutive complessive, le quali conferiscono coordinazione e fluenza all’atto motorio, al comportamento e al pensiero del bambino, lo rendono attivo e operativo nei contesti di vita, rapido nel rispondere alle molteplici richieste dell’ambiente attraverso la proposta di attività sensoriali, motorie e prassiche. Per quanto concerne lo sviluppo delle FE in età prescolare, un bambino con notevoli difficoltà ad inibire il movimento a 4 anni (a 3 anni tale competenza inizia a maturare) andrà supportato e facilitato soprattutto sull’area del controllo inibitorio, che rappresenta la base per lo sviluppo delle competenze successive, partendo sempre da un lavoro sul corpo e sui sistemi sensoriali. A 3 anni verranno proposte attività di gioco simbolico e con investimento corporeo/motorio e materiali destrutturati: tali attività, anche molto semplici, hanno inizialmente lo scopo di stimolare l’autoregolazione motoria per veicolare l’apprendimento per mezzo del corpo. L’investimento senso-motorio nel gioco deve essere sostenuto da attività motivanti con alta componente motoria ed emotiva. Un lavoro che stimoli l’inibizione della risposta automatica con un bambino di 5 anni consiste invece nella presentazione di un gioco che può essere svolto a terra su un tappetino o a tavolino attraverso l’utilizzo di macchinine, bambole, materiali da cucina, animali. In altri casi, soprattutto per i bambini di 5-6 anni, è possibile presentare i giochi in maniera strutturata, in modalità di conduzione più direttiva: verranno presentati dall’adulto i materiali e le regole dell’attività sollecitando la collaborazione, l’interesse e la motivazione del bambino, attraverso la varietà e la novità dei giochi (se l’adulto ha ben in mente l’obiettivo, la funzione da stimolare, i canali da utilizzare e le modalità di risposta da attendere, potrà creare giochi diversi e nuovi, con materiale differente, pur lavorando sul medesimo obiettivo). Un bambino che investe emotivamente e cognitivamente sull’attività userà più facilmente le sue risorse e attiverà in maniera più efficace i processi inibitori, di elaborazione in memoria di lavoro e di flessibilità cognitiva. Le attività di Inibizione si baseranno sull’inibizione motoria legata al tempo e allo spazio di attesa, alla percezione e alla regolazione del limite, alla modulazione tonico-emotiva. Si proporranno esercizi-gioco finalizzati a generare un’attesa, una risposta desiderata o automatica e ad allenare il bambino a posticipare la gratificazione, ad autoregolarsi in base alle situazioni, a controllare gli impulsi e le azioni, ad interrompere e modulare il proprio comportamento in maniera adeguata, al momento opportuno o nel contesto appropriato, a sperimentare strategie di controllo delle risposte e i vantaggi che da esse derivano. Nei bambini prescolari può essere utile insegnare loro ad inibire la risposta prevalente automatica attraverso giochi neuro-psicomotori che prevedano il cambiamento improvviso delle regole: ad esempio, il terapista/insegnante dice al bambino di correre e poi improvvisamente inserisce un’altra regola che è quella di saltare; oppure il terapista/insegnante dice al bambino di camminare velocemente quando sente la musica e di fermarsi quando viene stoppata. Le attività di Memoria di Lavoro si svolgeranno con l’attivazione del corpo e la manipolazione di oggetti concreti. Si proporranno esercizi-gioco che mirano a trattenere, manipolare e aggiornare le informazioni acquisite dal bambino. Ad esempio, si invita un bambino di 4-5 anni a gattonare/strisciare/correre/camminare all’interno del setting occupando tutto lo spazio a disposizione e a ripetere in ordine diretto uno span di 2 parole denominate dall’adulto; oppure a saltare nei cerchi a piedi uniti e a pronunciare nomi di animali nei cerchi gialli e nomi di frutti in quelli rossi, aumentando gradualmente lo span verbale da 2 a 4 elementi. Pertanto, una delle strategie più efficaci è quella di “muoversi per memorizzare”: è più facile memorizzare qualcosa che ha comportato un’interazione diretta e un coinvolgimento della motricità, piuttosto che un concetto astratto. Per questo motivo i bambini devono fare esperienze dirette e associare ai movimenti l’acquisizione di nuovi concetti. Ad esempio, possiamo proporre al bambino prescolare la ripetizione di una filastrocca o di una canzoncina e contemporaneamente eseguire un girotondo, battere le mani e poi i piedi, o colorare (dunque realizzare sinestesie verbo-motorie per una migliore capacità di memorizzazione). E’ inoltre fondamentale favorire le associazioni tra rappresentazioni motorie e apprendimento attraverso una tecnica che è stata definita «apprendimento recitato»: tale tecnica sfrutta il fatto che le memorie motorie (legate alle ripetizioni e al raffinamento dell’esecuzione di un determinato movimento) sono particolarmente solide, mentre quelle semantiche (le memorie legate al significato delle parole) sono più fragili. Si invita il bambino ad imparare una semplice poesia o i giorni della settimana mimandoli attraverso gesti che rievocano i significati. Spesso i bambini faticano a memorizzare qualcosa anche per pochi secondi e tendono a perdere il filo di ciò che stanno svolgendo, che sia un gioco o un’attività cognitiva semplice come disegnare, fare puzzle, giocare con le costruzioni. Rispetto ai coetanei, i bambini con difficoltà nella ML non riescono a seguire un’attività per un tempo appropriato e talvolta mostrano lentezza o difficoltà nel terminare i compiti intrapresi a scuola, a casa e in terapia. Capacità adeguate di ML permettono al bambino di mantenere attive le informazioni rilevanti di cui ha bisogno per l’esecuzione di un’attività, come completare un gioco o dare una risposta. Possiamo aiutarli a costruire delle strategie mnemoniche promuovendo le componenti visive, spaziali-sequenziali e verbali, attraverso la suddivisione di compiti in sottounità, l’introduzione di varie pause associando anche attività motorie con le strategie verbali, oppure invitarli a ripetere le istruzioni che diamo prima di iniziare un compito e a rievocare le informazioni anche attraverso supporti visivi. Le attività di Flessibilità saranno impostate richiedendo semplici spostamenti di attenzione e di elaborazione da uno stimolo all’altro o da una tipologia di risposta all’altra, sempre con l’utilizzo di oggetti concreti. Si presenteranno compiti motori ad alto investimento corporeo, con poche variabili da gestire contemporaneamente. Nel stimolare tale competenza vengono coinvolti anche altri domini quali inibizione e memoria di lavoro a seconda della richiesta che viene fatta al piccolo; bisogna abituare il bambino a passare velocemente da un compito all’altro in autonomia in base alle informazioni ricevute e a passare da un compito al suo inverso (ad esempio, se l’adulto esegue un salto dentro un cerchio, il bambino lo farà fuori dal cerchio, se alza un braccio il bambino dovrà abbassarlo, e così via). Si possono introdurre anche attività che includano il cambiamento improvviso di regole, l’utilizzo non convenzionale di oggetti (utilizzare un oggetto al posto di un altro, come un mattoncino facendo finta che sia una macchina), l’introduzione di nuovo materiale e di variazioni in un gioco prestabilito, l’uso di immagini che il bambino dovrà categorizzare per forma e colore (in tal modo imparerà a passare da un criterio di categorizzazione ad un altro). Altre strategie riguardano la proposta di giochi simbolici e attività che prevedano lo scambio dei ruoli (ad esempio il bambino fa il maestro e l’adulto fa l’alunno) oppure giochi interattivi che includano regole: attraverso la loro improvvisa variazione, il terapista o l’educatore può stimolare la capacità del bambino di adattarsi, divertendosi, in maniera flessibile ai cambiamenti del contesto gioco. E’ importante in tal senso segnalare quando sta avvenendo il cambiamento di regole e che si proponga in modo alternato la vecchia versione di gioco con la nuova, al fine di far apprezzare al bambino le novità e i cambiamenti inaspettati e accettare l’imprevedibilità. Per lo sviluppo o il potenziamento delle FE in età prescolare, si possono eseguire anche attività in gruppo stimolando la partecipazione attiva, la collaborazione sociale, la capacità di autoregolarsi di fronte a regole condivise e gestite in maniera sempre più autonoma. Le attività di gruppo andranno adattate in base agli obiettivi che vogliamo far raggiungere a ciascun bambino, all’età di maturazione neuro-psicomotoria dei partecipanti al gruppo e alle motivazioni. Le FE sono assolutamente pervasive nel quotidiano ed entrano in gioco non solo nelle attività ludiche e prassico-motorie del bambino, ma anche nelle attività scolastiche come, ad esempio, nella realizzazione di un testo. Elaborare un testo chiama in causa differenti domini esecutivi quali pianificazione logica e del pensiero, attenzione selettiva e sostenuta, mantenimento in memoria delle informazioni, flessibilità, autocontrollo costante e capacità di autocorrezione, processi di sequenzialità-successione e processi spazio-temporali. Il disprassico presenta difficoltà nella coordinazione sinestesica di tutte queste abilità, ovvero nel ricordare gli eventi da narrare o i concetti, la loro successione temporale, nel tradurre il pensiero in parole sul foglio, nel rispettare lo spazio e la punteggiatura, nel prestare attenzione a non compiere ripetizioni e a scrivere informazioni rilevanti e coerenti con il testo, nel non commettere errori ortografici e nel mantenere una buona sintassi. Per aiutare il bambino si può costruire insieme all’insegnante o al professionista una “scaletta” del testo da scrivere con dei punti chiave (Chi è il protagonista? Che cosa fa? Quali sono i personaggi secondari? Dove e quando si svolge la storia? Cosa accade? Come si conclude la storia?, ecc.) in modo che la sequenza logica e la scansione temporale degli eventi vengano rispettate. Terminato il brano, bisogna indirizzare il bambino verso l’autocorrezione e l’autocontrollo fornendo regole semplici e chiare sulla punteggiatura, e lavorare sulla prosodia migliorando l’intonazione, dopo aver ascoltato l’adulto che ha letto con espressione il prodotto finale. Evitare la brutta copia, che genererebbe eccessiva fatica e aumenterebbe il numero di errori ortografici, inficiando negativamente sulla qualità della prestazione grafica. Anche l’utilizzo del diario mette in gioco una serie di abilità critiche per i disprassici, ascrivibili alle Funzioni Esecutive: risulta complesso trovare il mese e il giorno giusto, suddividere i compiti per materia all’interno della stessa pagina, copiare i compiti per casa dalla lavagna o scriverli sotto dettatura. Sarebbe quindi opportuno che ogni giornata avesse la sua pagina con data e giorno della settimana ben evidenziati, lo spazio della pagina chiaro e grande, senza troppi disegni o scritte inutili, lo sfondo non colorato o a quadretti troppo piccoli, l’interlinea di almeno 1,5 cm. Possono essere stabiliti un posto e un colore per ogni materia ed essere messe in evidenza verifiche e interrogazioni; si consigliano strumenti per i ragazzi con difficoltà nell’organizzazione del diario strutturati su un planning settimanale. Un accorgimento adottabile dagli insegnanti è quello di fornire avvisi prestampati o supervisionare il bambino quando sta scrivendo i compiti sul diario, almeno fino all’acquisizione di una sua maggiore autonomia. Le Funzioni Esecutive entrano in gioco nel complesso processo di studio: è necessaria l’intenzionalità, la pianificazione del compito e il problem-solving, la stima del tempo necessario, la memoria per recuperare le informazioni che servono ad eseguire una consegna, la verifica dell’adeguatezza del compito e l’eventuale correzione, oltre a saper utilizzare le immagini mentali in modo funzionale e flessibile. I disprassici hanno notevoli problemi spaziali e temporali e materie come la geografia e la storia possono rappresentare ostacoli insormontabili. La geografia presuppone un’organizzazione spaziale ben acquisita e la capacità di saper individuare confini, coordinate e rapporti tra gli elementi: si consiglia di utilizzare supporti concreti, cartine tattili, componibili, puzzle; per quanto riguarda la storia, oltre ai problemi legati alla collocazione spaziale, emerge una difficoltà a livello temporale, nel saper rispettare la successione degli eventi e nel muoversi nella giusta direzione lungo la linea del tempo. Come facilitazione si potrebbero costruire le linee del tempo concrete, mappe mentali o far rappresentare, recitando, le vicende storiche. A cura della Dott.ssa Francesca Tabellione
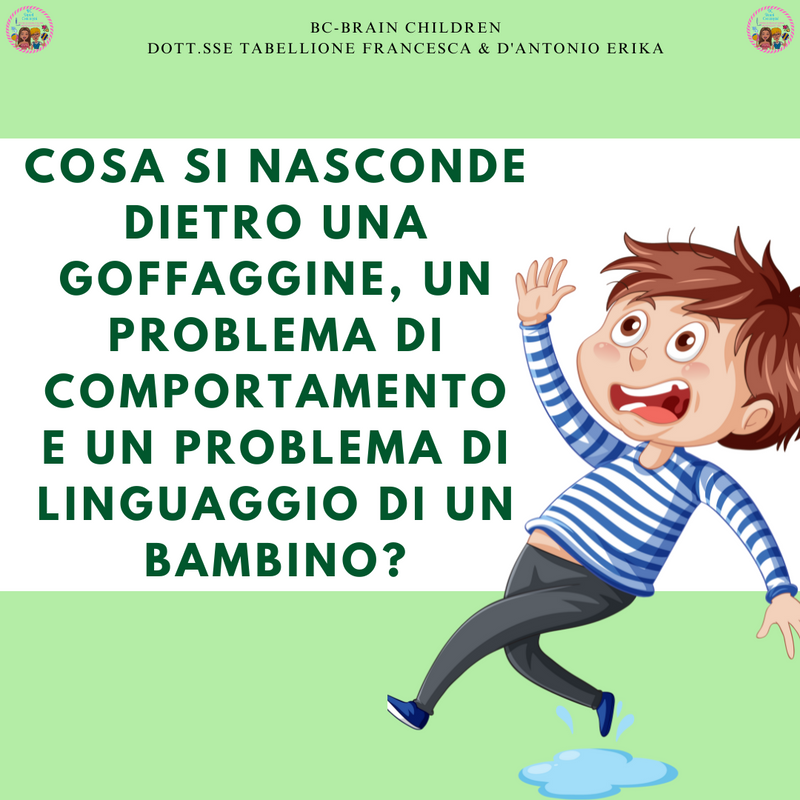
da admin
COSA SI NASCONDE DIETRO UNA GOFFAGGINE, UN PROBLEMA DI COMPORTAMENTO E UN PROBLEMA DI LINGUAGGIO DI UN BAMBINO⁉️
DIETRO UNA GOFFAGGINE"Mio figlio si stanca facilmente e si ferma quando succhia il latte dal seno, preferisce alcune consistenze particolari di cibo, manifesta una frequente salivazione con tendenza a tenere la bocca aperta, fatica nei passaggi posturali, ha una ritardo nella deambulazione, è impacciato nei movimenti e a livello coordinativo, ogni cosa che tocca la rompe o la fa cadere, non riesce a impugnare bene le posate o la matita, non è capace di afferrare una palla di normali dimensioni con le mani ma spesso la afferra con gli avambracci supinati e dopo vari tentativi, non ha una idonea percezione del proprio corpo e non sa quanta distanza intercorre tra il proprio corpo e altri oggetti: per tale ragione cade di frequente, inciampa o sbatte contro i mobili o le persone, non riesce a capire come posizionare il proprio corpo per infilarsi la giacca o le scarpe e per pianificare un'azione, quando salta perde l'equilibrio o stacca poco i piedi da terra, ha paura delle altezze e dei giochi come scivolo e altalene" DIETRO UN PROBLEMA DI COMPORTAMENTO "Mio figlio è ipercinetico (non sta mai fermo), è in continua agitazione ed è irrequieto, sembra come "mosso da un motore", interrompe gli altri quando parlano, non ascolta e sembra avere la testa tra le nuvole, sembra apparentemente "pigro e svogliato" (ma non si tratta di cattiva educazione da parte dei famigliari o di un atteggiamento volontario del bambino, piuttosto di qualcosa che sta accadendo all'interno del suo sistema nervoso non visibile ai nostri occhi e che raramente consideriamo come un vero e proprio "segnale d'allerta" per poter intervenire precocemente), passa da un gioco o compito all'altro senza mai portarlo a termine, fa fatica a concentrarsi e non riesce a seguire un discorso/una domanda/un cartone, non rispetta le regole e non tollera i tempi di attesa, non pensa prima di agire finendo spesso "nei guai", ha atteggiamenti controllanti e da leader verso i suoi pari, vuole imporre le sue idee, non tollera i rimproveri e le frustrazioni adottando atteggiamenti aggressivi o oppositivi" DIETRO UN PROBLEMA DI LINGUAGGIO "Mio figlio manifesta un'assenza del gesto deittico - non indica per richiedere un oggetto desiderato, non condivide con il caregiver l'attenzione e l'emozione verso un gioco (l'attenzione condivisa - guardare insieme, verso - una persona, un oggetto o un evento rappresenta un importante requisito per il normale sviluppo cognitivo del bambino, in particolare per lo sviluppo del linguaggio, per lo sviluppo delle abilità relazionali e per la capacità di comprendere il punto di vista dell’altro. Questa abilità si realizza tramite la condivisione dello sguardo o di un gesto che permette di stabilire, mantenere e dirigere l’attenzione), vi è un'assenza del gioco simbolico tra i 18 e 24 mesi (il gioco simbolico è una modalità di gioco in cui il bambino rappresenta, attraverso il materiale che ha a disposizione, qualcosa che non è presente realmente e permette al bambino di fare un'esperienza creativa, simbolica, motoria e sensoriale. Durante questa modalità di gioco, i bambini non stanno “imitando” qualcuno o qualcosa, ma stanno “interpretando” a loro piacimento una storia. Proprio per questo motivo, il gioco simbolico diventa un modo per esprimere la sfera affettiva, emotiva e relazionale del bambino e per arricchire il proprio lessico), un'assenza della lallazione e un ritardo di linguaggio manifestando, a circa 2 anni, un vocabolario di sole 20 parole (sebbene la lallazione inizi molto prima, di solito intorno agli 8-9 mesi, lo sviluppo del linguaggio vero e proprio, in cui il bambino prova a chiamare oggetti e persone associandoli a un nome, è successivo e si verifica, generalmente, tra i 13 e i 18 mesi. Di solito intorno ai 24 mesi il bambino ha sviluppato un vocabolario di circa 100 parole, ma è intorno ai 30 mesi che inizia a comporre vere e proprie frasi di più di due parole), non riesce a farsi comprendere comunicando solo attraverso i gesti e va in frustrazione, adottando di conseguenza atteggiamenti oppositivi o di pianto inconsolabile" Bene!, Se notate alcuni o molti di questi accurati SEGNI E SINTOMI CHE VI ABBIAMO ELENCATO, NON CI STANCHEREMO MAI DI RIPETERE DI INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE AL FINE DI EVITARE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SU TUTTO LO SVILUPPO DEL BAMBINO, da quello MOTORIO a quello AFFETTIVO-RELAZIONALE, EMOTIVO, COGNITIVO PERTANTO, VI INVITIAMO A UTILIZZARE GLI STRUMENTI VALUTATIVI FUNZIONALI DA NOI REALIZZATI (e che stiamo diffondendo non solo tra i professionisti ma anche tra gli insegnanti) CHE VI PERMETTERANNO DI SEGNALARE ED EVIDENZIARE PRECOCEMENTE ALCUNI ASPETTI MOTORIO-PRASSICI, COMPORTAMENTALI O COGNITIVI/SCOLASTICI DISFUNZIONALI, OVVERO NON IN LINEA CON L'ETÀ CRONOLOGICA DEL BAMBINO, CREATI APPOSITAMENTE E ACCURATAMENTE PER METTERE IN LUCE DISFUNZIONI QUALITATIVE (CHE ALTRIMENTI, CON I SOLI TEST QUANTITATIVI STANDARDIZZATI, NON EMERGEREBBERO!). (Articolo a cura della Dott.ssa Francesca Tabellione, tnpee- docente presso enti accreditati, specializzata in neuropedagogia dei processi cognitivi e psicomotricità neurofunzionale, terapista itard)
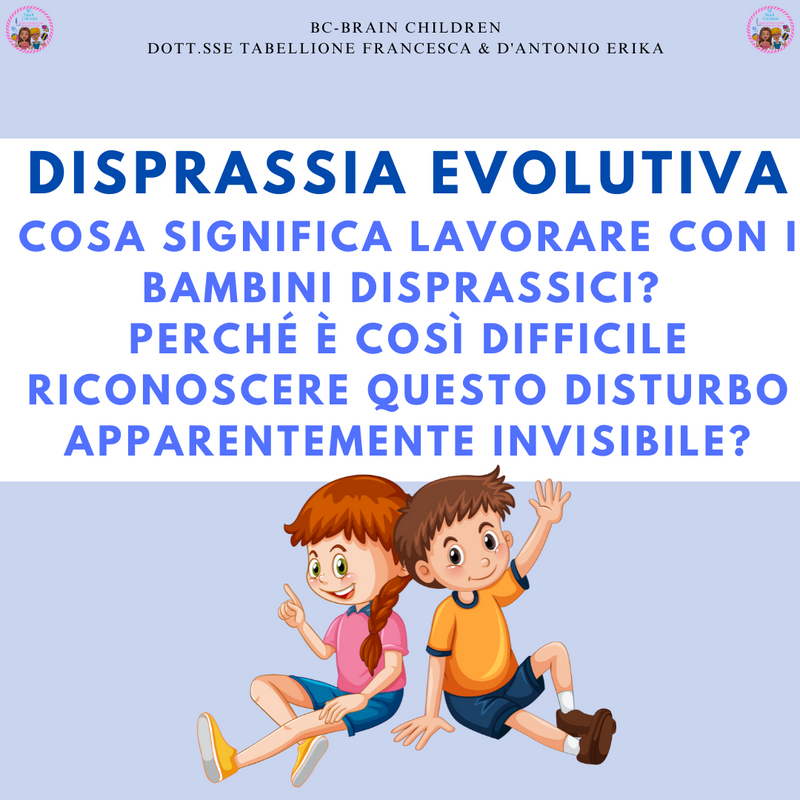
da admin
DISPRASSIA EVOLUTIVA: COSA SIGNIFICA LAVORARE CON I BAMBINI DISPRASSICI? E PERCHÉ È COSÌ DIFFICILE RICONOSCERE QUESTO DISTURBO APPARENTEMENTE INVISIBILE?
per lavorare con la disprassia e dsa DISPRASSIA – BC BRAIN CHILDREN DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - DSA – BC BRAIN CHILDREN

da admin
DISPRASSIA: DEFICIT O DISORDINE⁉️
per lavorare con la disprassia e dsa DISPRASSIA – BC BRAIN CHILDREN DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - DSA – BC BRAIN CHILDREN

da admin
L' AUTOREGOLAZIONE IN ETÀ PRESCOLARE: CAPACITÀ FONDAMENTALE PER LO SVILUPPO MOTORIO, COMPORTAMENTALE, EMOTIVO E COGNITIVO DEL BAMBINO
Iniziamo questo articolo interrogandoci su tali quesiti: --> Quando possiamo dire che un bambino è autoregolato e si sa controllare nei differenti contesti di vita (casa, scuola, sport)? --> Quando è semplicemente vivace o al contrario cela una disregolazione comportamentale di base dovuta ad una disfunzione esecutiva? -->Quando e a che età un bambino deve aver acquisito un buon autocontrollo sia motorio (comportamentale) e sia emotivo/cognitivo? Spesso noi professionisti ci troviamo di fronte a genitori o insegnanti che ci dicono “il bambino è svogliato, è pigro, quando vuole ce la fa, non ha voglia di impegnarsi e concentrarsi”. Attraverso questo articolo, quello che noi possiamo dirvi e su cui vogliamo che voi riflettiate è: “siete certi che tali atteggiamenti, come ad esempio una distrazione, una goffaggine motoria, un comportamento non autoregolato o uno scarso impegno dipendano dalla volontà di vostro figlio/alunno? O potrebbero essere il prodotto di un qualcosa di invisibile che sta accadendo all’interno del loro sistema nervoso, dunque di disfunzioni esecutive che “alterano" il comportamento, l’autocontrollo, la relazione e gli apprendimenti?”. Pertanto vi invitiamo a capire e conoscere insieme a noi cosa si nasconde dietro un determinato comportamento del bambino, in modo da poterlo aiutare a superare eventuali difficoltà che da solo non è in grado di affrontare perché privo dei corretti strumenti di cui necessita. La componente genetica è senza dubbio un fattore importante nell’eziologia dei vari disturbi dell’età evolutiva e un intervento tempestivo, in età precoce (prescolare), basato sulla stimolazione dei vari domini esecutivi ad iniziare principalmente dai processi inibitori, puó aiutare i bambini a ridurre notevolmente il rischio di alcuni disordini evolutivi, come il Disturbo dell’Autoregolazione che si caratterizza per una difficoltà nel controllo degli impulsi/istinti e delle emozioni, difficoltà nei tempi di attesa e di turnazione, nel mantenere e sostenere l’attenzione per un periodo di tempo prolungato, bassa tolleranza alla frustrazione, problemi nella working memory e nella flessibilità cognitiva, atteggiamenti aggressivi o oppositivi verso gli altri, ecc). Perché iniziare già dall’età prescolare? Premettendo che in età prescolare si osserva un incremento a carico di differenti domini esecutivi quali: - Controllo inibitorio e attentivo (Davidson, 2006) - Working memory o memoria di lavoro (Smith, 2008) - Flessibilità cognitiva (Zelazo, 2001), nella fascia d’età 3-6 anni i circuiti dei bambini non sono ancora ben connessi tra loro, le competenze non sono ancora così specializzate da limitare la generalizzazione dei risultati. In età precoce possiamo aiutare a ristabilire le corrette connessioni sinaptiche in modo che esse siano più stabili e consolidate nel tempo. Inoltre se stimoliamo il bambino in questo periodo temporale critico per lo sviluppo delle FE permetteremo al suo pensiero e al suo comportamento di organizzarsi con maggiore flessibilità e autocontrollo, minore rigidità e impulsività, e di acquisire schemi cognitivi che andranno a consolidarsi nell’architettura cerebrale del bambino grazie alla plasticità neurale tipica di questo momento. Recentemente Nigg (2017) ha individuato tre componenti o processi dell’autoregolazione: 💨cognitiva = capacità di focalizzare le proprie risorse cognitive nello svolgimento di un compito complesso, di mantenere e sostenere l’attenzione e le informazioni in memoria per svolgere un’attività, evitando gli stimoli interferenti o sopprimendo le risposte inadeguate e spostando il focus attentivo su altri elementi quando necessario. Dunque l’autoregolazione cognitiva include tre processi di base: controllo inibitorio- memoria di lavoro- flessibilità cognitiva, localizzati nelle regioni dorsolaterali dei lobi prefrontali. (Miyake, 2012). 💨comportamentale = capacità di controllare le proprie azioni motorie e i propri impulsi/ istinti. 💨emotiva = capacità di riconoscere e dare un nome alle emozioni, di elaborarle e controllarle in maniera adeguata, in particolare quelle negative, di tollerare la frustrazione. I processi emotivi sono localizzati nelle regioni orbitali e ventrali della corteccia prefrontale. Nella scuola dell’infanzia i bambini che mostrano una maggiore consapevolezza emotiva sono spesso quelli che riescono ad adattarsi meglio all’ambiente, a tollerare la frustrazione o gli insuccessi, le delusioni, le reazioni di rabbia, manifestano meno problemi comportamentali e un miglior rendimento scolastico, sanno relazionarsi adeguatamente con i loro coetanei. A loro volta, la regolazione emotiva e cognitiva sono funzionali alla regolazione del comportamento in generale al fine di raggiungere i propri obiettivi. Per valutare l’autoregolazione emotiva in età prescolare viene spesso utilizzato il paradigma della “delusione indotta", in cui un bambino riceve un gioco indesiderato (Cole, 1986) e viene osservata la sua reazione nel risolvere lo stato di delusione che prova. Oppure alcuni ricercatori hanno usato la procedura della scatola trasparente per generare frustrazione e rabbia: al bambino viene mostrato un gioco che viene poi messo in una scatola trasparente chiusa a chiave. L’adulto mostra al bambino come aprire la scatola con la chiave e gli permette di esercitarsi ma poi, senza farsene accorgere, cambia chiave e la consegna a lui, uscendo dalla stanza. L’adulto, che osserva il bambino tramite uno specchio unidirezionale, gli dice che può giocare con il giocattolo solo se riesce ad aprire la scatola con le chiavi (che in realtà sono sbagliate): in tal modo si valuta se il bambino è capace di gestire la rabbia e la frustrazione dovute all'incapacità di aprire la scatola. COS’È L’AUTOREGOLAZIONE? È la capacità di percepire le informazioni sensoriali provenienti dall’ambiente esterno e dal proprio corpo e di processarle ed organizzarle correttamente, oltre alla sinergia tra gli aspetti cognitivi ed emotivi, a consentire al bambino l’acquisizione di comportamenti autoregolati e autocontrollati al fine di raggiungere uno scopo e di rispondere adeguatamente alle richieste ambientali. L’autoregolazione, abilità fondamentale dello sviluppo umano, è la capacità che hanno gli individui di modificare in maniera adattiva il proprio comportamento in risposta alle circostanze ambientali in continuo mutamento e in risposta alle richieste sociali, dunque la capacità di modulare il comportamento, le emozioni, l’attenzione (Fuster, 1997). Un ruolo fondamentale per sviluppare l’autoregolazione è ricoperto dalle FE, che sono processi cognitivi di ordine superiore, riconducibili alla corteccia prefrontale, deputate al controllo, alla pianificazione e alla regolazione o monitoraggio del proprio comportamento al fine di raggiungere uno scopo. Possedere FE ben organizzate permetterà al bambino di raggiungere non solo migliori prestazioni in campo scolastico e/o professionale ma anche un’adeguata regolazione del comportamento emotivo e sociale. Da un punto di vista evolutivo, già dal primo anno di vita il bambino inizia a regolare i propri stati di attivazione inseguendo un oggetto che si muove nel suo campo visivo e distogliendo lo sguardo dalla fonte di interesse, riesce a inibire certi comportamenti passando a nuovi schemi di risposta, ad esempio orientando la ricerca di un oggetto desiderato in posizioni diverse da quelle in cui l’oggetto era stato trovato precedentemente dal bambino (Diamond, 1985). Durante la scuola dell’infanzia, le capacità di autoregolazione si sviluppano maggiormente: il bambino inizia a pianificare una serie di azioni per raggiungere piccoli obiettivi, a inibire o avviare un gioco, ad inibire azioni verbali, emotive o motorie automatiche preponderanti o impulsi inadeguati al contesto, a esprimere meglio le proprie emozioni durante i giochi, a farsi valere e prendere decisioni, a ritardare il soddisfacimento di una gratificazione immediata per una successiva più attraente soprattutto a partire dai 4 anni e mezzo (si riduce l’impulsività tipica della fascia d’età prescolare), ad accrescere il suo repertorio di schemi motori, a rispondere in maniera più idonea alle richieste sociali e cognitive del suo ambiente (Posner, 2007). Anche alcune semplici attività di flessibilità cognitiva, in cui al bambino viene richiesto di cambiare rapidamente set di risposta tra un compito e l’altro, ad esempio classificare degli oggetti prima in base al colore e poi in base alla forma, vengono superati dal bambino a partire dai 4 anni, quando cominciano a maturare i processi inibitori. Il disturbo dell’autoregolazione più diffuso e noto in età evolutiva è il Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), caratterizzato da difficoltà nella flessibilità cognitiva, nella pianificazione, nella memoria di lavoro visuo-spaziale, nel mantenimento dell’attenzione per periodi di tempo prolungati, difficoltà nel controllo motorio e degli impulsi, dunque un disordine pervasivo che può interessare l’intera sfera sociale, emotiva, scolastica del bambino. La diagnosi può essere fatta con sicurezza in età scolare, sebbene molti campanelli di allarme possano essere colti già a partire dall’età prescolare, sotto forma di rigidità comportamentale, deficit di inibizione e disregolazione emotiva. In particolare, l’inibizione osservata in età prescolare risultava essere predittiva dei deficit di attenzione e iperattività a 5 e 13 anni. Una ricerca condotta su 82 bambini di età 3-6 anni ha dimostrato che bambini con difficoltà nella memoria di lavoro, nei compiti di ricerca visiva e categorizzazione mostrano con più frequenza comportamenti dirompenti e disregolati. Un altro studio condotto su 235 bambini di 5 anni ha dimostrato che quelli che a 6 anni mostrano migliori capacità inibitorie, due anni dopo presentano migliori competenze sociali e di controllo del proprio comportamento in risposta alle richieste verbali. E’ stato osservato che i disordini delle Funzioni Esecutive osservati a 4 anni predicevano inoltre i comportamenti-problema rilevati a 5 anni. QUALI SONO I PRINCIPALI CAMPANELLI D’ALLARME IN ETÀ PRE-SCOLARE CHE POSSONO PREDIRE UN FUTURO DISTURBO DELL’AUTOREGOLAZIONE? 🗨 difficoltà nel controllo dei propri impulsi (non sanno attendere, né rispettare la turnazione o le regole all’interno di un gruppo di pari, sono bambini estremamente impulsivi, frettolosi, invadenti e possono essere provocatori, caotici e disorganizzati, non riescono a pensare prima di agire) 🗨 difficoltà nel controllo delle proprie risposte emotive (possono avere reazioni esagerate quando vivono emozioni intense positive o negative e quando sperimentano insuccessi e frustrazioni, manifestare reazioni bizzarre o anomale durante momenti stressanti o di forte pressione emotiva) 🗨 ipercinesia e iperattività (non riescono a controllare il proprio movimento, a stare tranquilli, né a rimanere seduti per terminare l’attività che hanno iniziato o a tavolino quando il contesto lo richiede, ad esempio a scuola quando svolgono giochi o durante i pasti, sono spesso irrequieti) 🗨 difficoltà nel problem-solving e nella memoria di lavoro o a breve termine (sono bambini disorganizzati e disordinati, fanno fatica nell’esecuzione di compiti che richiedono più passaggi sequenziali, nell’organizzare un gioco, nel fare puzzle, nel ricordare due o più consegne, ad esempio “prendi i colori e mettili nello zaino, salta nei cerchi blu e poi in quelli rossi”) 🗨 attenzione labile e discontinua (sono bambini che impiegano molte energie durante la loro giornata e tendono a stancarsi facilmente, presentano una disorganizzazione spazio-temporale, tutti fattori questi che inducono a una dispersione attentiva e a uno smarrimento cognitivo generale con notevole insofferenza verso gli stimoli laterali-visivi o uditivi) 🗨 difficoltà a livello relazionale, ovvero nell’instaurare rapporti adeguati con i loro pari, con facile tendenza all’isolamento. COME POSSIAMO SVILUPPARE L’AUTOREGOLAZIONE IN ETÀ PRE-SCOLARE? E QUALI STRATEGIE ADOTTARE? Il nostro approccio abilitativo, quando si lavora con i bambini, consiste nel proporre attività-giochi neuropsicomotori all’interno del setting che, attraverso la motricità (le competenze prassico-motorie), organizzano la cognitività stimolando o potenziando i differenti domini delle FE (attenzione, memoria di lavoro, inibizione, pianificazione, categorizzazione, flessibilità cognitiva o shifting). Fondamentale sarà poi la generalizzazione delle competenze acquisite e delle varie strategie adattive in altri contesti, in modo da trasferirle anche negli ambienti quotidiani. Tutte le abilità del bambino andranno valutate attentamente tramite un’osservazione qualitativa funzionale, per capire quali sono i suoi punti di debolezza e soprattutto i suoi punti di forza, poiché proprio da questi ultimi bisogna partire per impostare un training abilitativo in modo da mantenere sempre alto il livello di autostima e di motivazione del bambino, garantendo la costruzione del senso di autoefficacia e un miglior funzionamento cognitivo e delle abilità di autoregolazione. Spesso i bambini disregolati vengono continuamente richiamati e rimproverati nel contesto familiare e scolastico a causa del loro comportamento inappropriato e non conforme alle regole sociali, senza considerare che non è un comportamento intenzionale che mettono in atto o dovuto a una scarsa educazione ma un problema relativo alla mancanza di autocontrollo: lavorare sulle deficienze o carenze non farebbe altro che peggiorare il senso di frustrazione che tali bambini avvertono e che inevitabilmente avrà ripercussioni negative sulle FE stesse. Un bambino che a 4 anni fa fatica ad inibire il proprio movimento (a 3 anni inizia a maturare il controllo inibitorio), andrà supportato a far emergere tale abilità, indispensabile per lo sviluppo delle competenze successive. È bene considerare sia l’età cronologica del bambino (per non fare richieste troppo elevate) ma soprattutto l’età di maturazione psicomotoria e le competenze di autoregolazione durante la presentazione delle attività con alto investimento corporeo e prassico-motorio. Da ricordare che quando stiamo ideando e progettando un esercizio è difficile riuscire a scindere il singolo dominio esecutivo su cui vogliamo concentrarci dagli altri; bisogna essere consapevoli che tali funzioni esecutive si sviluppano in maniera progressiva e sono strettamente interrelati fra loro, e che non esistono attività specifiche che stimolino una singola FE. Pertanto, all’interno di uno stesso compito/gioco spesso più di un dominio esecutivo viene messo in campo. Le strategie da poter adottare per rendere il bambino con disfunzioni esecutive più autoregolato e organizzato nella sua vita quotidiana sono le seguenti: 🗨ridurre al minimo le fonti di distrazione strutturando un ambiente che sia il più possibile prevedibile e lineare per non disorganizzare il bambino (strutturare uno spazio per la motricità, uno per le attività cognitive, un altro ancora per il gioco spontaneo, ecc.) 🗨dare poche regole semplici e chiare 🗨dare due o più consegne in sequenza al fine di sviluppare la memoria di lavoro, evitando l’eccessiva reiterazione delle consegne 🗨organizzare attività in piccoli gruppi per stimolare la relazione, lo scambio reciproco, il rispetto delle regole, la turnazione 🗨usare mimica e gestualità a supporto del linguaggio verbale per consentire al bambino di comprendere e ricordare meglio una consegna data 🗨se il bambino fa fatica nel completare un gioco o un’attività scomporre gli stessi in passaggi più brevi consentendo il movimento e introducendo pause frequenti per incrementare i tempi di attenzione e concentrazione 🗨non dare punizioni quando il bambino ha atteggiamenti inappropriati ma manifestare comprensione, fornire feedback positivi, gratificazioni immediate o incoraggiamenti al fine di aumentare il senso di autoefficacia e autostima, rinforzare il comportamento adeguato alle richieste in modo da permettere al bambino di generalizzarlo in altri contesti 🗨proporre attività stimolanti e a difficoltà crescente partendo dall’interesse del bambino e variarle notevolmente man mano che vengono apprese per evitare che egli si annoi. Introdurre rinforzi sociali, fisici o emotivi e supportare il bambino nello svolgimento del compito senza sostituirsi a lui 🗨 sollecitare il gioco simbolico dal primo fino al sesto anno di vita per stimolare lo sviluppo socio-affettivo, la memoria di lavoro, il controllo dell’inibizione, e giochi prassico-motori o sensoriali in età prescolare per rafforzare le FE, in particolare la capacità di autocontrollo e autoregolazione, la pianificazione, il problem-solving, l’organizzazione spazio-temporale, l’attesa, la concentrazione, la memoria sequenziale (Diamond, 2011) 🗨 incoraggiare attività di resocontazione (narrazioni) per sviluppare l’organizzazione del pensiero e la sequenzialità, favorendo la costruzione dei nessi causali e temporali tra gli eventi, attraverso la descrizione di immagini semplici e complesse, l’ascolto di storie mettendo in ordine temporale le immagini che descrivono le varie sequenze e infine raccontarle. 💢 Se vuoi apprendere come impostare un trattamento abilitativo con un bambino che manifesta disordini delle Funzioni Esecutive e quali esercizi/giochi neuropsicomotori proporgli, vi aspettiamo al nostro corso “Allenare le Funzioni Esecutive in età prescolare 3-6 anni" 💢 (Articolo a cura della Dott.ssa Francesca Tabellione, Erika D’Antonio, tnpee- docenti presso enti accreditati, specializzate in neuropedagogia dei processi cognitivi e psicomotricità neurofunzionale, terapiste itard)
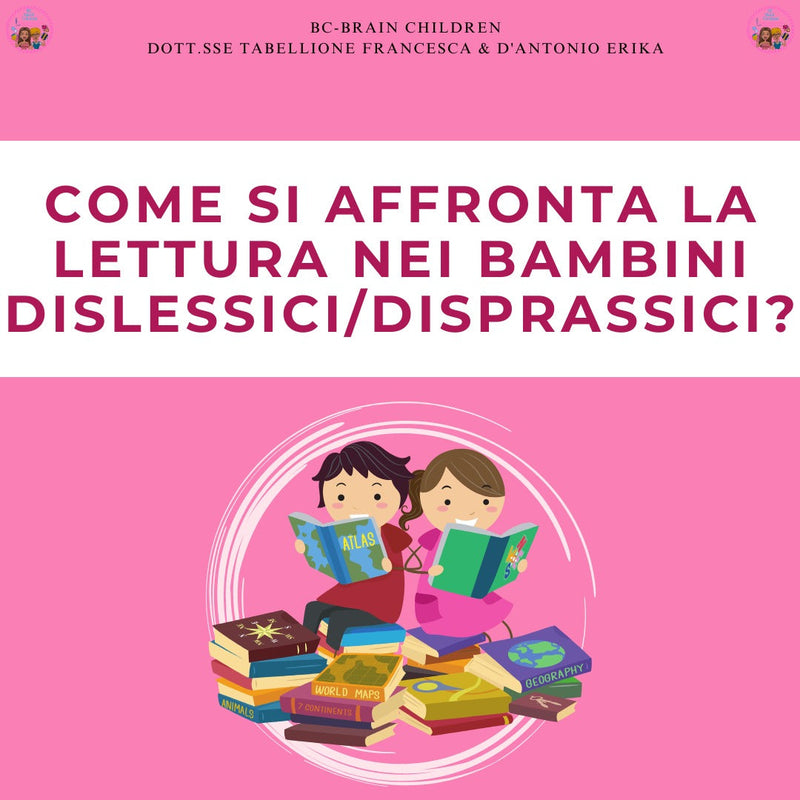
da Erika
SUPPORTARE LA LETTURA DEL BAMBINO DISPRASSICO
La lettura del bambino disprassico, si presenta spesso disfluente, lenta nell’incipit e precipitosa nell’esecuzione, aprosodica (senza intonazione e senza rispetto della punteggiatura). Inoltre si osserva una difficoltà nello spostamento dall’immagine al testo o viceversa, nel mantenimento stabile del rigo di lettura e nell’andare a capo, a causa di una incoordinazione dei movimenti oculari saccadici. Tutte queste caratteristiche portano il bambino a una dis-comprensione del brano che legge. Pertanto è opportuno aiutarlo facendo “recitare” il testo, enfatizzando così il significato e la componente emotiva del contenuto, oppure l’adulto può leggere ad alta voce il brano con espressione e intonazione. Si sconsigliano le pratiche educative lente, frammentate, discontinue, orientate alla disfluenza: queste pratiche educative o abilitative hanno lo scopo di migliorare la correttezza morfologica-grammaticale delle lettere attraverso la lettura o scrittura frammentata ma rallentano l’esecuzione e disperdono gli automatismi, stancano, affaticano i processi cognitivi e creano demotivazione. Evitare anche l’utilizzo di strumenti che suppliscono la funzione e si sostituiscono alla lettura (sintetizzatori, libri digitali), ad eccezione di prove scolastiche finali, dal momento che favorirebbero l’inerzia cognitiva senza stimolare l’organo e la funzione, tendendo a bypassare il compito; non favorire la lettura di singole lettere o sillabe (lettura sintetica, ad approccio analitico), la lettura lenta e precisa, la lettura sub-vocale (sottovoce), la lettura su caratteri grandi; non correggere o fermare il bambino mentre scrive o legge; non insistere a farlo leggere ad alta voce o nella copiatura dalla lavagna, né leggere o scrivere al suo posto. Piuttosto bisognerebbe promuovere la lettura o scrittura in corsivo di parole intere, verbalizzando l’intera parola o enunciato prima di scrivere; la lettura a incipit rapido; la lettura fluida (giusta velocità, scarse interruzioni e inciampi, rapido incipit, rapida autocorrezione); la lettura predittiva (“a scomparsa”), globale, lessicale; la lettura obliqua. Scegliere testi ben contrastati rispetto allo sfondo, con un’interlinea maggiorata (a partire da 1,5) e prediligere la lettura di caratteri normo-dimensionati (in genere Times New Roman, 12 o 14) e ravvicinati (lettere a corpo grande, secondo le ricerche dell’istituto ITARD, appesantiscono lo scorrimento lettorio sulla riga. Se lo spazio occupato è minore, ovvero se le lettere sono piccole e lo spazio tra loro contenuto, si avrà un processo percettivo migliore, al cosiddetto “colpo d’occhio” e la prestazione lettoria sarà maggiormente fluida e meno interessata da interruzioni o disfluenza: il dislessico reca uno span visivo più corto, pertanto si può affermare che la vicinanza delle lettere agevola la lettura). E’ importante inoltre favorire anticipazioni cognitive sul testo ed esercitare la narrazione e la resocontazione, sollecitando forme espanse (solo per la comprensione invece, si possono utilizzare mappe e schemi in modo che il bambino comprenda senza smarrirsi nelle sequenze). Attivare lo stato di allerta con costanti feedback cognitivi (attivazione funzionale) durante la spiegazione orale prolungata, ovvero promuovere l’attenzione del bambino e la comprensione attraverso domande di monitoraggio, riformulazioni, ripetizioni di ciò che si sta spiegando o didascalie. A cura della Dott.ssa Francesca Tabellione

da Erika
SUPPORTARE LA SCRITTURA DEL BAMBINO DISPRASSICO
La scrittura del bambino disprassico, è caratterizzata da alterazioni nella forma delle lettere, nei collegamenti, nelle dimensioni e nei rapporti, in particolare nel corsivo; lo spazio foglio non è ben organizzato e non vi è un rispetto dei margini e del rigo di base. Un altro sintomo che spesso si evidenzia è la presenza di dolori frequenti o crampi al braccio e alla mano scrivente. Per questo è importante che l’insegnante e i professionisti prestino attenzione alla lunghezza dei brani che propongono. Osservare la postura che assume il bambino, spesso alterata, e la prensione dello strumento grafico: si consiglia il piano obliquo come supporto alla scrittura e di correggere le prese che non sono funzionali e che impediscono il controllo e la fluidità del movimento visuo-grafomotorio, anche se spesso ci sono prese da non correggere sebbene siano scorrette, poiché non provocano problemi e non ostacolano la scrittura. Sarebbe utile creare momenti di defaticamento attraverso esercizi relativi al rilassamento e alla tonicità della grande e piccola progressione (spalla-braccio-gomito-polso-mano-dita), in particolare per i bambini che presentano una Disgrafia Disprassica, i quali si affaticano facilmente durante l’atto scrittorio e necessitano di tempi di recupero. L’insegnante o il professionista deve dettare lentamente un testo e sceglierlo breve. Si suggerisce inoltre di introdurre il corsivo sin dal primo anno della scuola primaria attraverso diversi canali sensoriali: come ci insegnavano Maria Montessori (2010) e Bruno Munari (2006), le lettere vanno esplorate e conosciute prima con il movimento del corpo e con la manipolazione (le lettere si possono esplorare con il tatto e con la vista, costruendole con materiali differenti come corde, paste modellabili, chiodini) in modo che il bambino le interiorizzi sotto forma di immagini mentali stabili, e successivamente si possono realizzare sul foglio. Selezionare gli strumenti (quaderni, matite, penne, gomme) in modo appropriato e scegliere i quaderni in base all’attività da svolgere: si predilige il quaderno sottile che non contenga troppi fogli per non creare per la mano e per il polso dei dislivelli quando si gira la pagina (utilizzare il formato A5, il formato A4 spesso è troppo grande rispetto alla crescita del bambino). I quaderni ad anelli sono sconsigliati, poiché ostacolano il corretto movimento di progressione e il bambino, per poter scrivere all’inizio della pagina, deve cercare una posizione e una postura non del tutto funzionali. Durante la prima fase di intervento è molto importante utilizzare, indipendentemente dalla classe di appartenenza, il quaderno con quadretti di circa 1 cm, oppure il quaderno a rigatura grande o con rigatura colorata per facilitare il bambino, avviandolo gradualmente al rispetto del rigo di scrittura. Oltre a evidenziare lo spazio utile per la scrittura, il quaderno con rigatura colorata offre riferimenti cromatici verticali che indicano l’inizio e la fine del rigo (rispetto del margine e delle spaziature). Un altro suggerimento consiste nell’evidenziare il punto di partenza e la riga o il quadretto su cui scrivere con un puntino laterale. Si consiglia all’insegnante o al terapista, consapevole delle difficoltà del bambino, di proporre attività di scrittura via via più complesse seguendo i suoi tempi. Non appena il bambino si sente sicuro e mostra di aver raggiunto adeguate capacità grafo-motorie, può utilizzare il quaderno della classe di appartenenza. Nella scuola primaria, soprattutto durante le verifiche, ci si può avvalere di materiale fotocopiato per ridurre il carico di scrittura e concentrarsi sul contenuto più che sulla forma: la fotocopia non deve essere caotica, disordinata o tutta scritta, ma gli elementi devono essere pochi, comprensibili, scritti con un font chiaro ben contrastato e ben organizzato a livello spaziale. Se si propongono schede con esercizi da completare, bisogna prestare attenzione allo spazio disponibile per il completamento, che deve essere di dimensioni congrue, deve prevedere linee definite come facilitatori, evitando i puntini che invece potrebbero disorganizzare e confondere. Sia nella scuola primaria che secondaria, si sconsiglia alle insegnanti l’utilizzo dei raccoglitori nelle due direzioni per due materie diverse (ad es. italiano e matematica), che può generare caos nel bambino, mentre si preferisce caratterizzare ogni materia con una copertina di colore differente e con un’etichettatura chiara del nome della materia stessa per migliorare l’ordine e l’organizzazione del lavoro. La scrittura a mano (in corsivo) rimane importante anche quando è faticoso: numerosi studi hanno evidenziato l’importanza della percezione dell’orientamento e verso delle lettere nella scrittura, del tempo necessario per apprendere, dell’attivazione delle aree del linguaggio durante l’atto scrittorio, del miglioramento delle abilità di lettura e di resocontazione, del vocabolario, della motricità fine e di tutti i processi esecutivi (attenzione, memorizzazione dei concetti, autocontrollo, pianificazione, organizzazione e flessibilità del pensiero, strutturazione spazio-temporale). A cura della Dott.ssa Francesca Tabellione ••••• DISPONIBILE PER L'ACQUISTO IN PDF •••••••• GRAFOMOTRICITA' – BC BRAIN CHILDREN