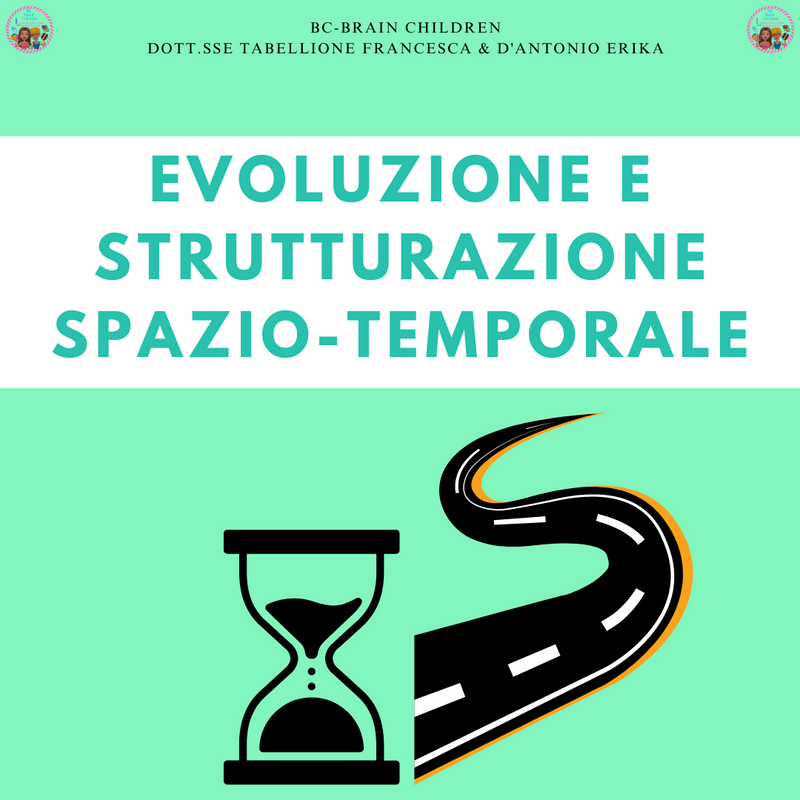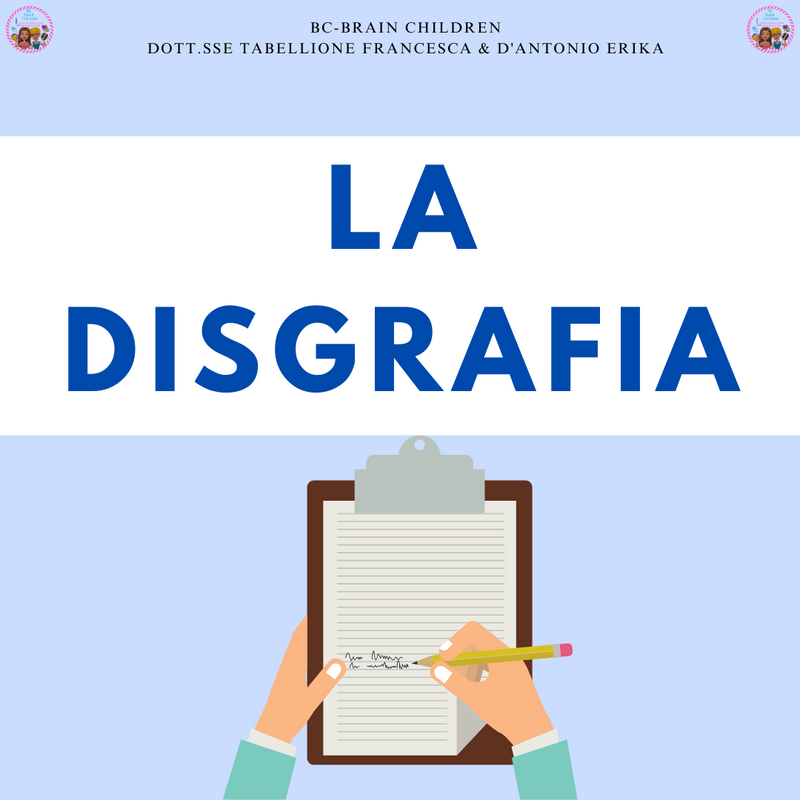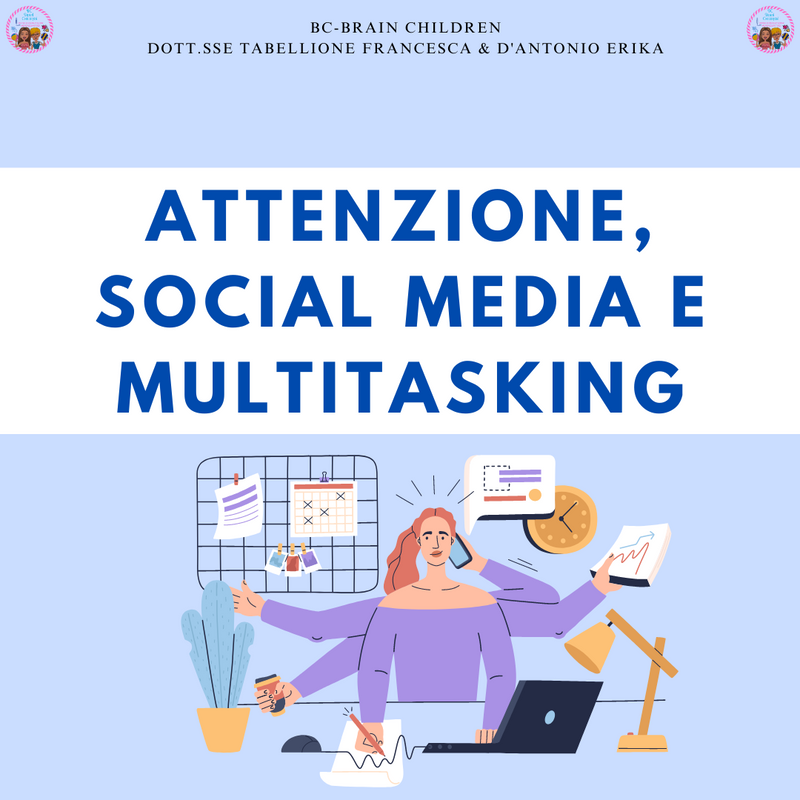
da admin
ATTENZIONE, SOCIAL MEDIA e MULTITASKING
Quanto l'attenzione dei nostri bambini è oggi influenzata dai social media!? -------------------------------------------- Il segreto nascosto sin dall'origine della nostra specie è la potenza della mente e della personalità infantili. I bambini mentre giocano stanno lavorando, giocare è un vero e proprio lavoro come lo definiva la Montessori. Il lavoro concentrato è alla base di ogni sviluppo del bambino, di ogni sua più semplice scoperta, di empatia e di dialogo con altri bambini: la stessa socializzazione è un frutto che deriva dal seme della concentrazione. E' necessario coinvolgere il piccolo in attività stimolanti e motivanti, lasciandolo talvolta libero di focalizzare la sua attenzione verso qualcosa che gli interessa senza disturbarlo. Fin dalla nascita i bambini sono capaci di concentrarsi su qualcosa, nonostante l'ambiente esterno possa sollecitare maggiormente tale processo. Così facendo il piccolo favorisce le proprie connessioni neurali e sviluppa le immagini mentali, diventando sempre più bravo a concentrarsi, aumentando la durata e la frequenza della sua attenzione. Scegliere con cura le attività, attendere senza mettere fretta né ansia: l'educatore deve essere il "custode" dell'attenzione del bambino, deve preparare l'ambiente e i materiali, in base all'età di sviluppo, e aspettare per ricevere dal bambino indicazioni su come poterlo aiutare senza ostacolarlo. Lasciargli i suoi spazi quando è richiesto è fondamentale. "Saper riconoscere gli istanti preziosi della concentrazione e incanalarla adeguatamente è importante al fine di poterli utilizzare nell'insegnamento". Un bambino distratto soffre gli stimoli laterali (visivi, uditivi, tattili, propriocettivi, ecc), è un bambino che non riesce ad inibire gli stimoli irrilevanti, dunque è in balia degli stimoli ambientali. Quando si concentra, invece, la sua mente si sviluppa, il suo cervello crea numerose connessioni, la sua organizzazione aumenta e la sua personalità si costruisce. Nell'era digitale come la nostra, con i bambini che utilizzano smartphone non come strumenti ma come vere e proprie protesi portatili, la distrazione è continua e costante. Quella che si sviluppa è un'attenzione discontinua e parziale: i bambini sono sempre in allerta per ogni tipo di messaggio che ricevono. La concentrazione è legata alla motivazione, ovvero l'interesse e il coinvolgimento sicuramente aumentano i livelli attentivi del soggetto (come nel caso del gioco libero e spontaneo) ma possiede anche una sua logica interna. Ma come funziona l'attenzione Che cosa ci dicono oggi le neuroscienze Esse confermano che l'attenzione è un potente strumento della mente: le funzioni esecutive quali pianificazione-shifting- inibizione-attenzione-memoria-controllo esecutivo sono componenti fondamentali del pensiero. I nostri sensi ricevono 11 milioni di informazioni al secondo e soltanto 40 consapevolmente. Esiste inoltre una stretta relazione tra memoria e attenzione: la memoria di lavoro (a breve termine) produce un cambiamento nella funzione delle sinapsi, potenziando o indebolendo le connessioni preesistenti. La memoria a lungo termine invece richiede variazioni anatomiche. Nel caso di un ricordo, quando esso è pienamente consolidato, sembra che venga cancellato dall'ippocampo dove era conservato e la corteccia diventa la sua unica sede. Quali sono le differenze tra la mente umana e l'intelligenza artificiale di un computer? Mentre il "cervello artificiale" elabora le informazioni salvandole direttamente nella sua memoria, il cervello umano continua questo processo di elaborazione dopo averle acquisite e la qualità di quei ricordi dipende da come l'informazione è stata elaborata. LA MEMORIA BIOLOGICA È VIVA, QUELLA INFORMATICA NO! Pertanto, la chiave per il consolidamento dei ricordi è l'attenzione: più i tempi attentivi sono lunghi, più acuta è la memoria. Il cervello consuma energia e tempi ogniqualvolta sospende un processo che implica attenzione per avviarne un altro, il cosiddetto "costo di switching". Per tale ragione non bisognerebbe mai interrompere un bambino quando lo vediamo coinvolto e attento nel portare a termine un compito o gioco: le frequenti interruzioni creano discontinuità, rallentano, disperdono l'agire e l'automatismo, stancano, indeboliscono il pensiero e la memoria, rendono meno empatici e più ansiosi o tesi. Social media e multitasking promuovono un passaggio rapido da un'attività all'altra e non ad un lavoro in parallelo. La tecnologia, pur avendo per certi versi aspetti positivi, immerge il bambino in un continuo stato di distrazione, di eccitazione e anche di agitazione, vivendo in una sorta di "parziale e discontinua attenzione". Stiamo andando incontro ad un epoca in cui il cervello infantile si sta modificando a causa dello sviluppo della tecnologia: mentre un sano libro ci permette di espandere l'immaginazione e il pensiero, di concentrarci, di articolare un discorso, di sviluppare il linguaggio e il vocabolario, i social-network ci travolgono con le loro mille sollecitazioni. Il nostro cervello, in particolare quello dei bambini, sta reagendo come meglio può alle accelerazioni e allo stress quotidiano cui è sottoposto. Le conseguenze? Già possiamo assistere nei nostri bambini ad una disorganizzazione motorio- prassica generale con goffaggine nella motricità generale e fine, incertezza nella programmazione di azioni, una disfluenza delle funzioni esecutive, lentezza e smarrimenti nel pensiero, nel linguaggio, nella lettura-scrittura-calcolo (apprendimento superficiale). Per quanto riguarda l'infanzia l'utilizzo educativo della tecnologia a scuola non è da prendersi in considerazione prima dei 6/8 anni. Nel periodo prescolare togliete tutto ciò che è di tecnologico o carta e matita. Lavorate invece con il corpo, dando assoluta priorità alle esperienze sensori-motorie, all'esplorazione e alla manipolazione dei diversi materiali, al fine di rappresentare la realtà circostante e organizzare la mente. La virtualizzazione, soprattutto nei confronti dei bambini, è un impoverimento sia delle capacità motorie che delle capacità relazionali e immaginative. I bambini apprendono attraverso il movimento, con l'agire e non stando fermi davanti ad un pc o giocando con i videogiochi (seppur interattivi). Bisogna tornare ad un tipo di educazione che la Montessori definiva "educazione sensoriale o sensori-motoria" soprattutto nel periodo sensibile dello sviluppo (0-6 anni) affinché il bambino possa creare giuste connessioni cerebrali e generare risposte adeguate ad ogni tipo di richiesta ambientale. Gli ultimi studi hanno riscontrato una relazione diretta tra l'eccesso di stimoli audiovisivi, il multitasking e la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (adhd). Inoltre hanno dimostrato che più un bambino utilizza il web e più deve lottare per riuscire a concentrarsi nel portare a termine un gioco o un compito scolastico (ad esempio testi lunghi): i bambini vengono più facilmente distratti da stimoli irrilevanti, e questo perché l'attenzione si abitua a brevi periodi e la rete la cattura soltanto per disperderla. Il mondo non può essere contenuto in uno schermo, altrimenti priviamo i bambini delle esperienze sensoriali, corporee e motorie fondamentali che devono fare per poter crescere in maniera adeguata, li priviamo di acquisire una buona padronanza dello schema corporeo al fine di pianificare e organizzare le prassie, instaurare rapporti duraturi con i pari, possedere un buon livello di attenzione e migliori capacità mnemoniche e cognitive. Dott.ssa Francesca Tabellione Dott.ssa Erika D’Antonio Tnpee, psicomotriciste funzionali, terapiste itard, supervisori, ideatrici di libri e schede educative/riabilitative