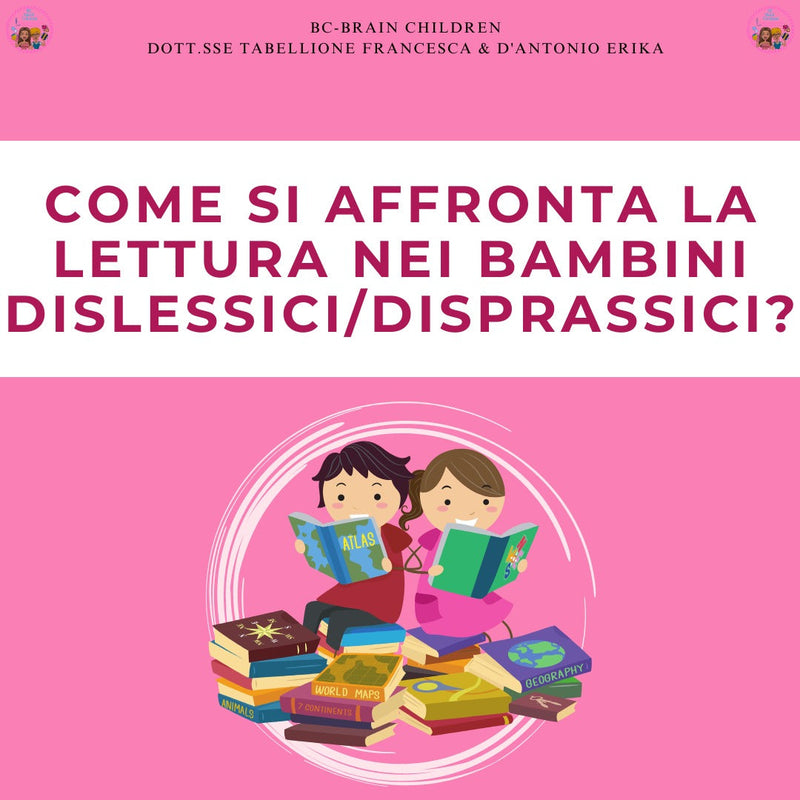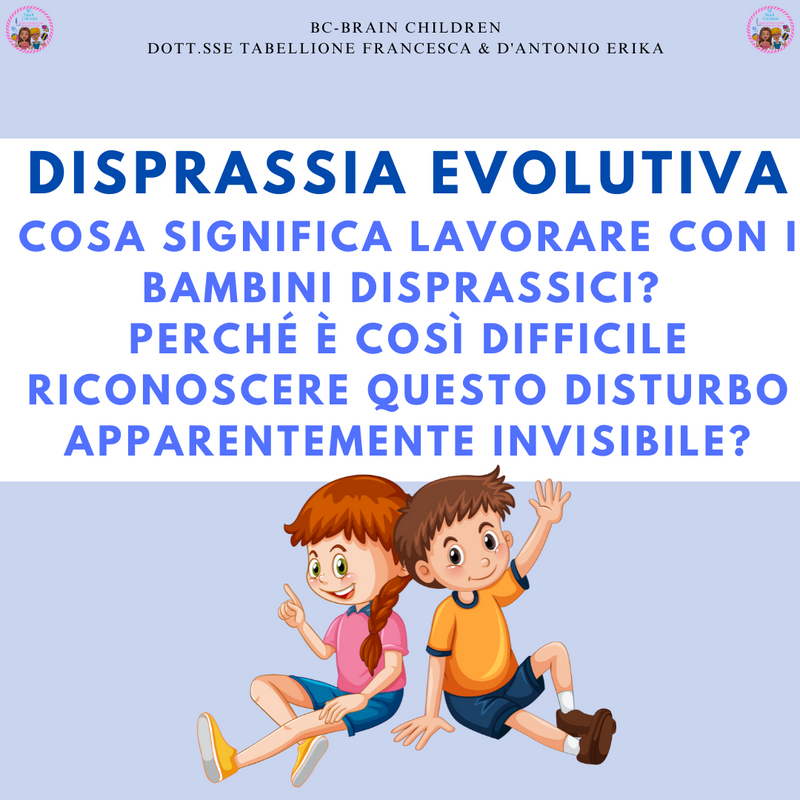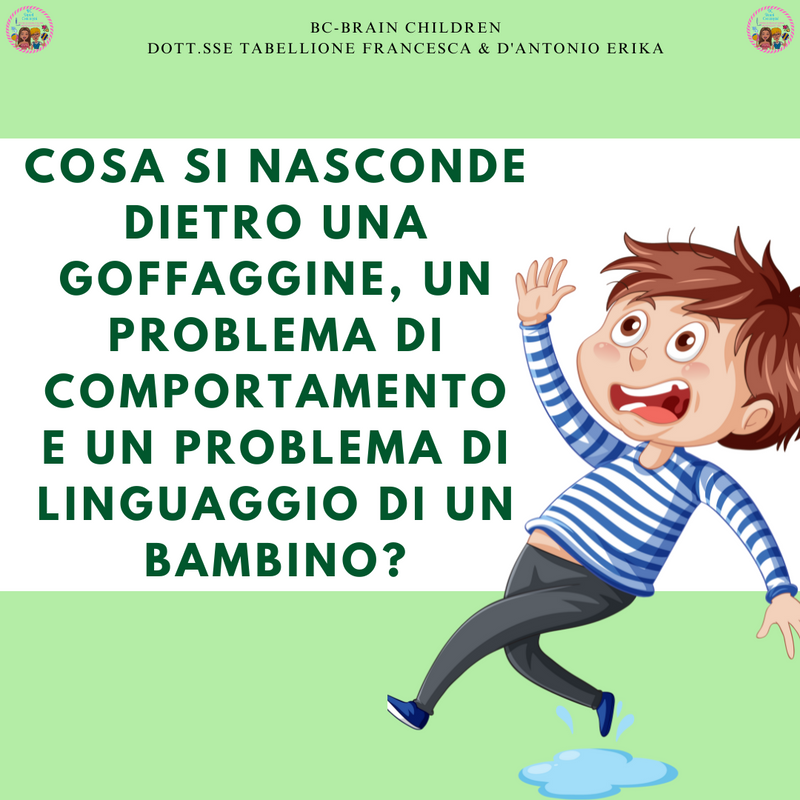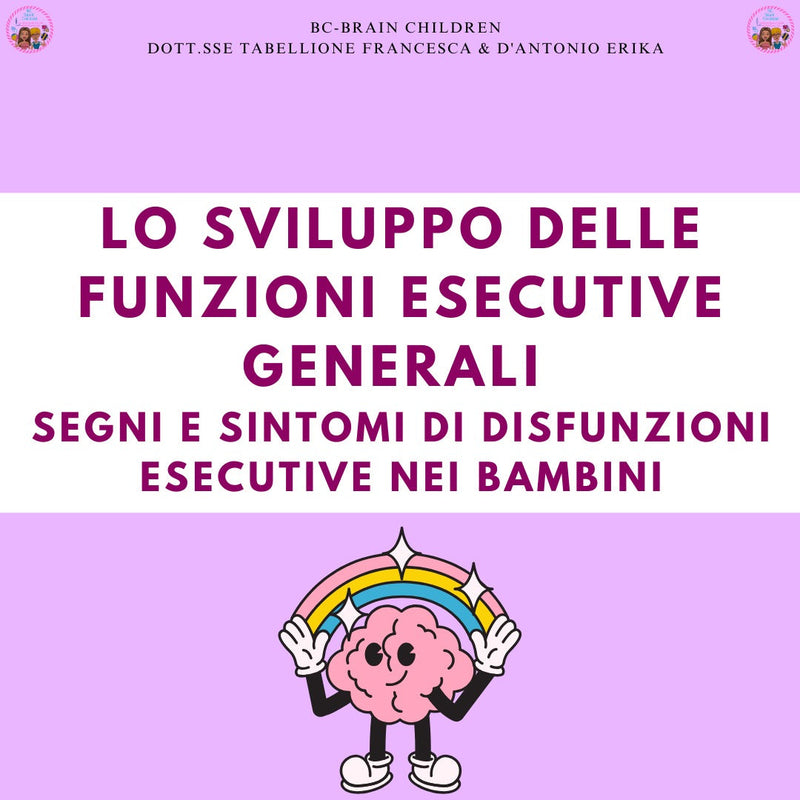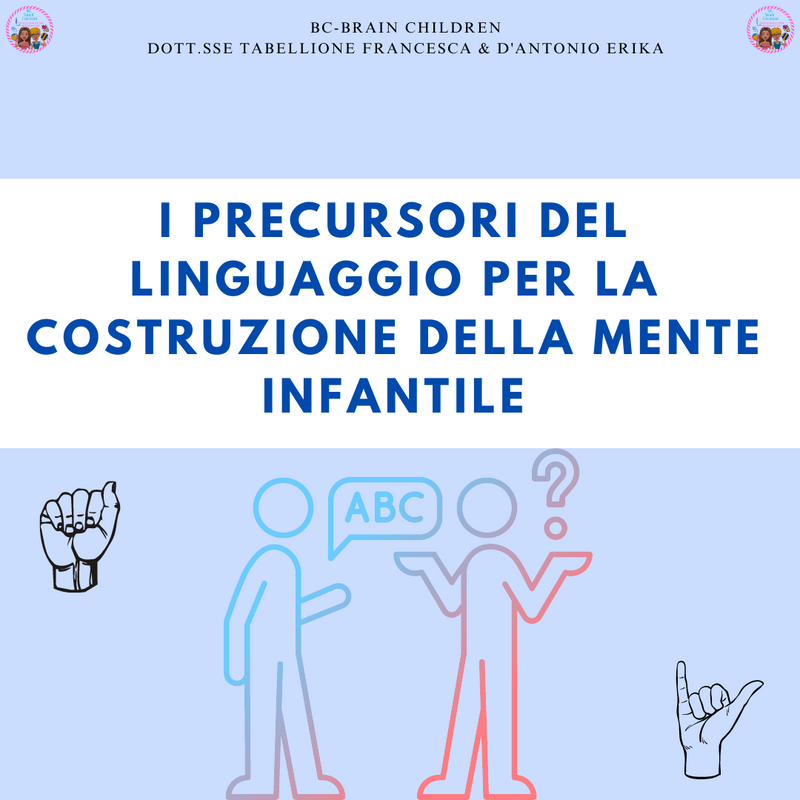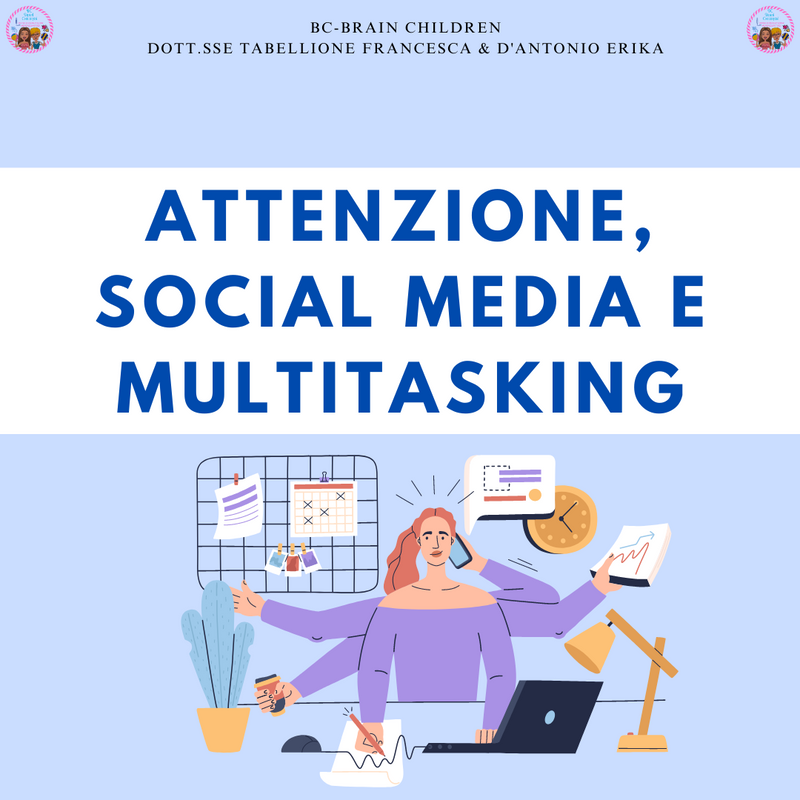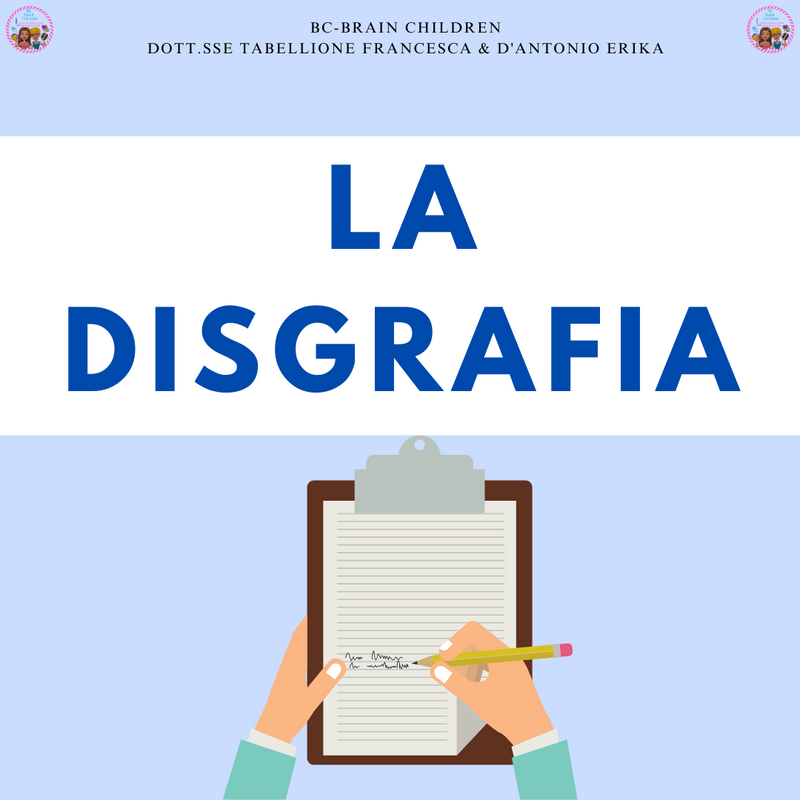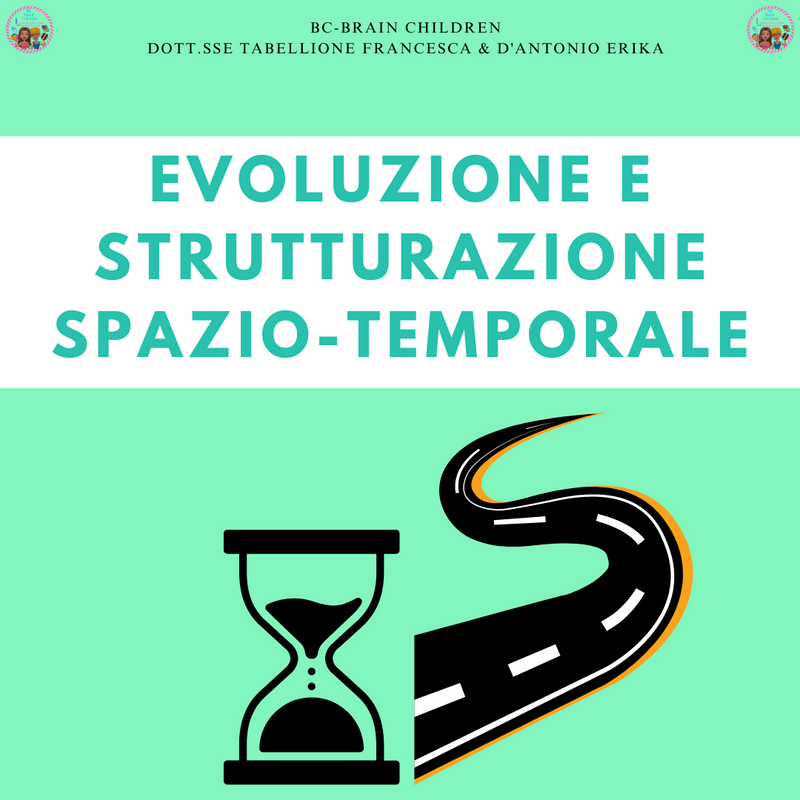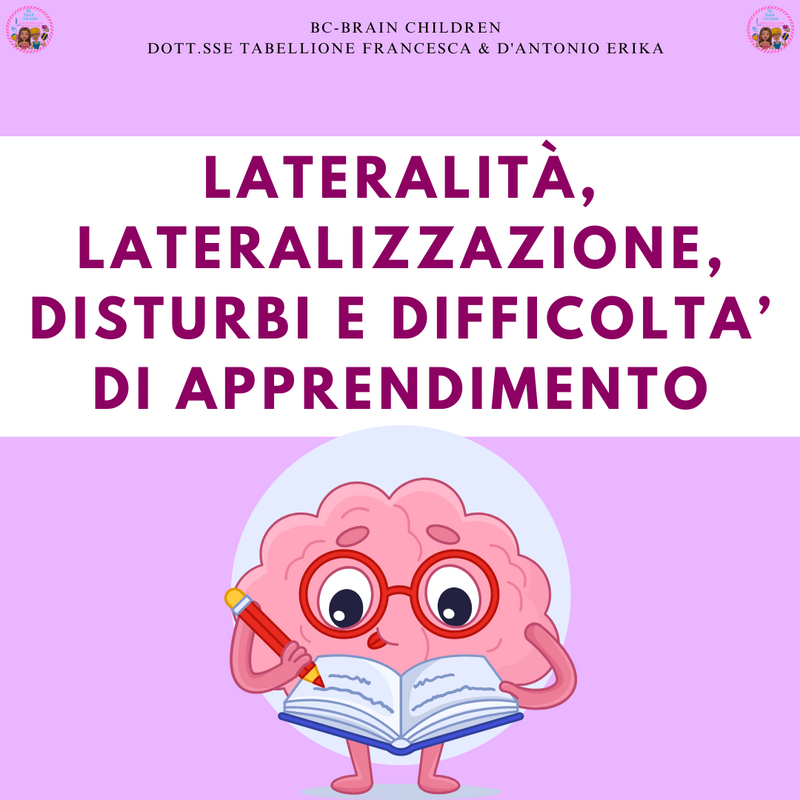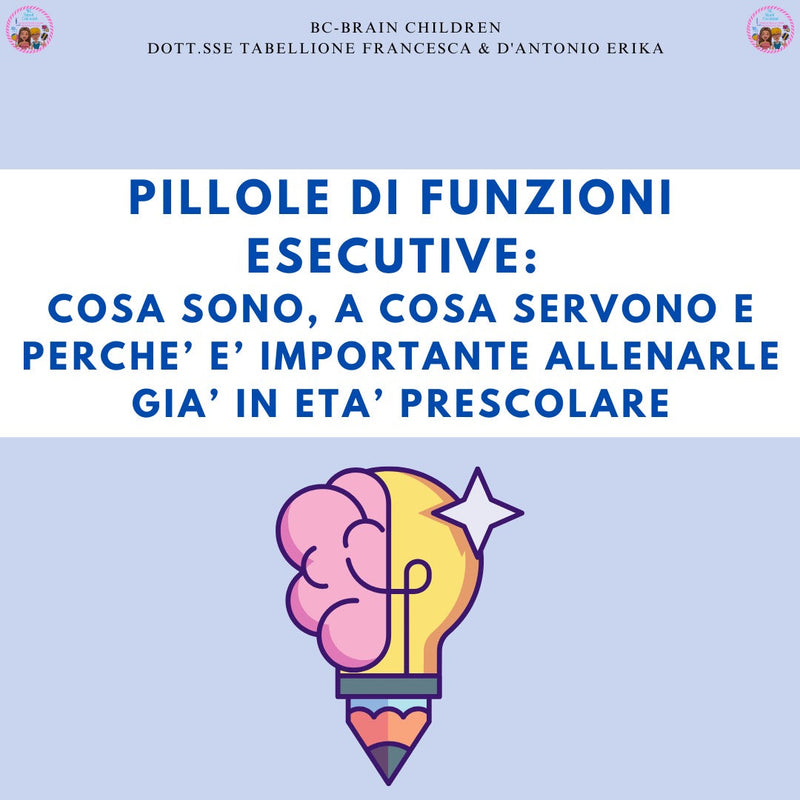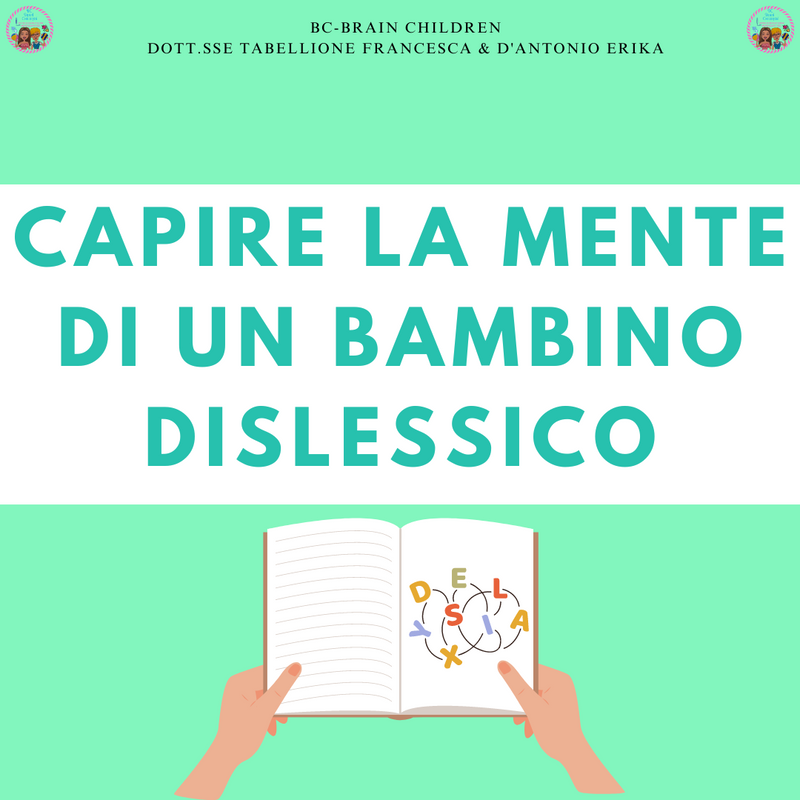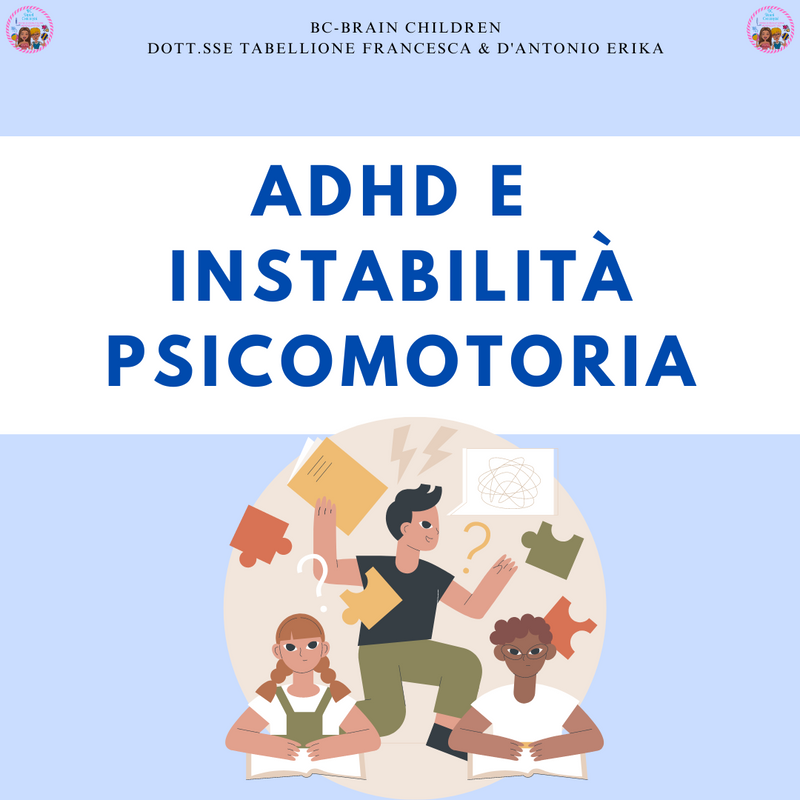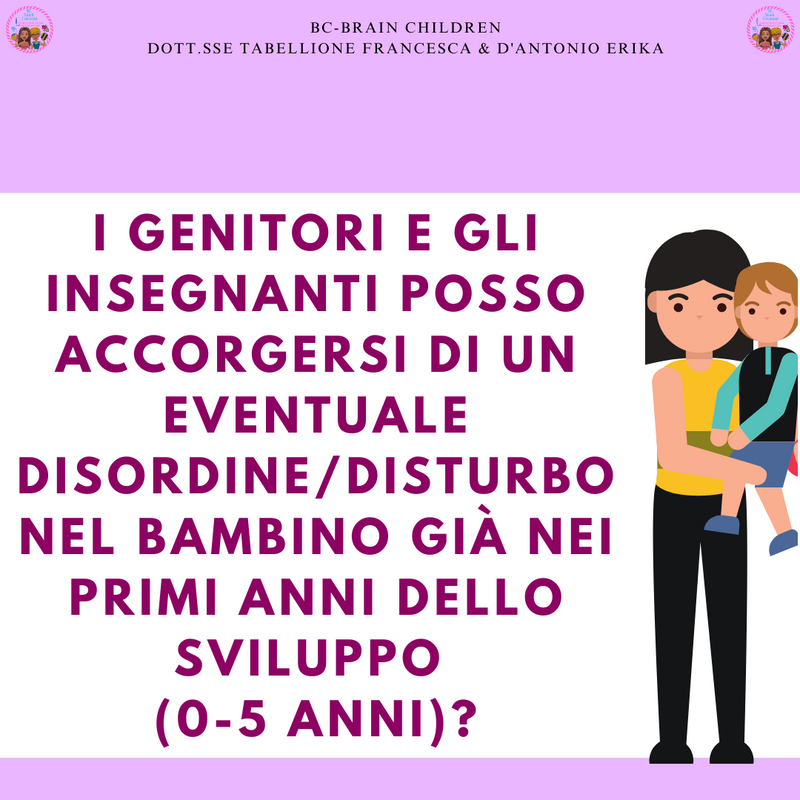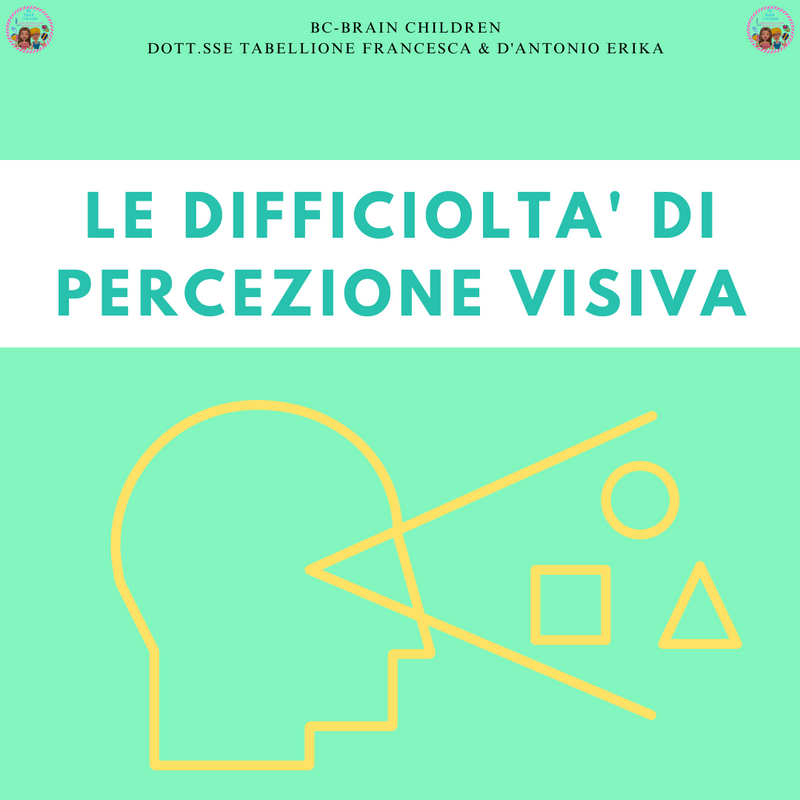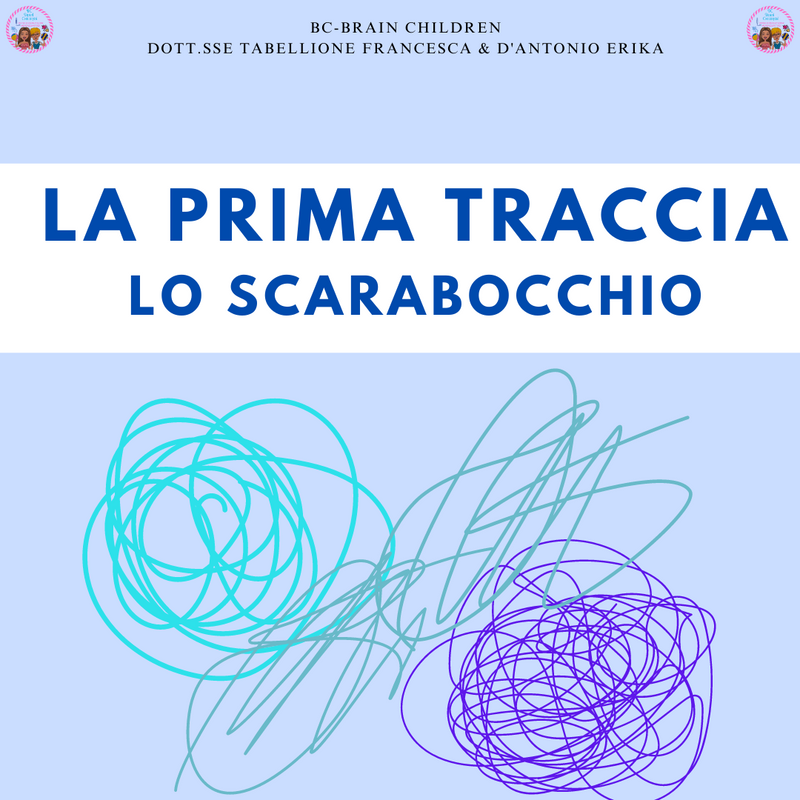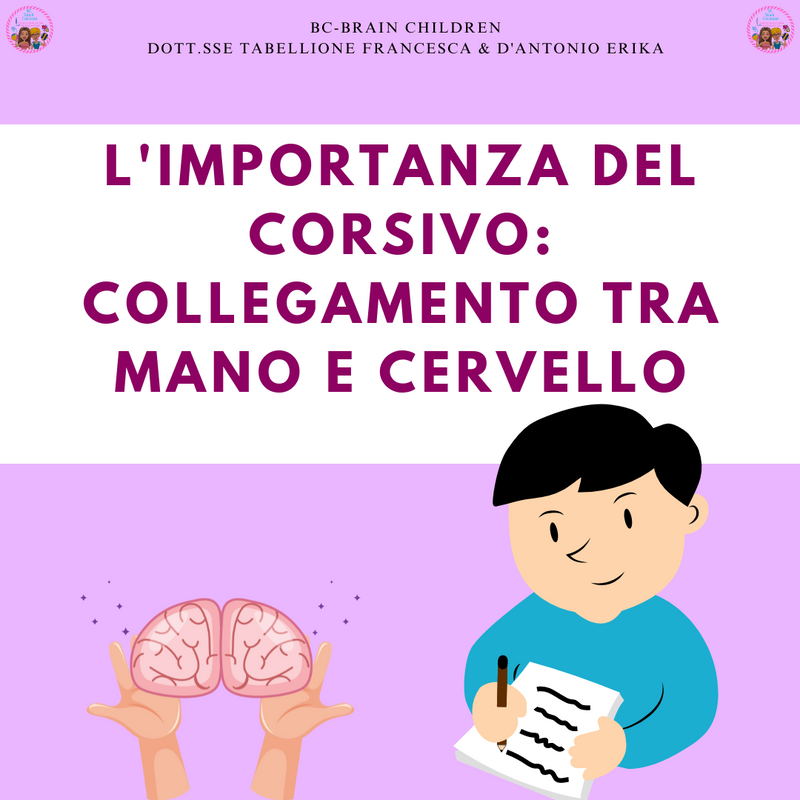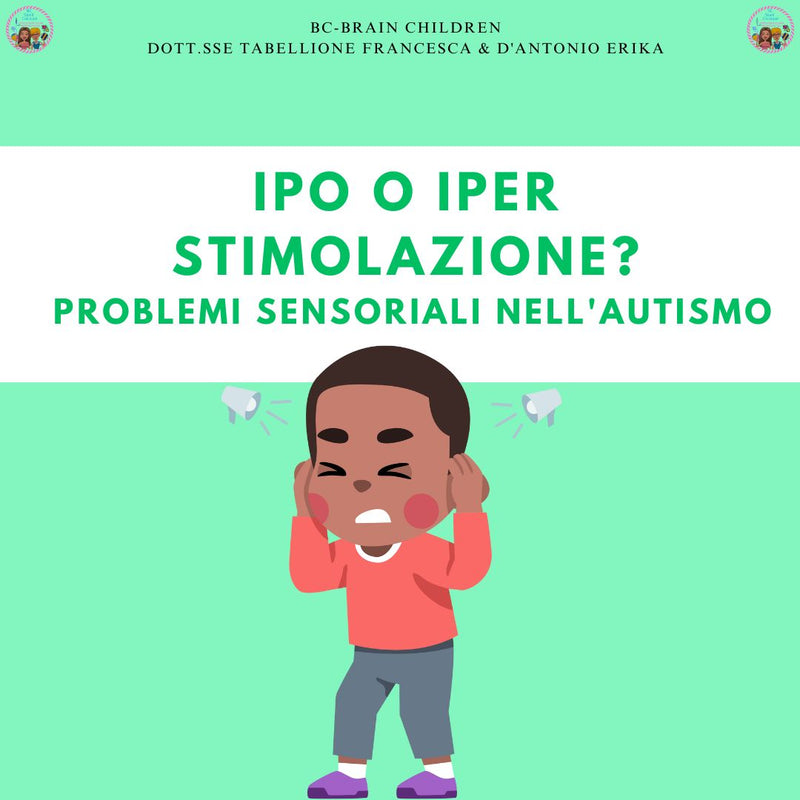I nostri Blog – da admin
CONOSCIAMO IL BAMBINO AUTISTICO: LA CORRELAZIONE CON I SISTEMI SENSORIALI E LA TERAPIA SENSORI-MOTORIA
a cura della Dott.ssa Francesca Tabellione
Specializzata nella valutazione e trattamento dei disordini dell’età evolutiva, supervisore, formatrice presso enti accreditati e ideatrice di volumi educativi/riabilitativi
—–‐—————————————————————–
VERSO UN NUOVO MONDO
Chi è il Bambino Autistico
Guardare un bambino che, senza fine e senza avvertire dolore, si morde una mano o fa ruotare oggetti in modo ipnotico; che è capace di fissare per ore con lo sguardo vuoto, un granello di polvere o che si colpisce senza fine o si spalma sul corpo le proprie feci; che vi ignora, respingendo ogni contatto umano; un bambino che non vi ascolterà né parlerà con voi, né spesso vi permetterà di toccarlo, che presenta un contatto oculare assente o sfuggente e che preferisce le cose alla gente, sempre solo e chiuso in se stesso, “uno straniero tra noi”, un tempo definito psicotico e segregato in ospedali psichiatrici.
Il suo comportamento sconosciuto ci è incomprensibile e quindi ci intimorisce. È possibile che questo comportamento strano contenga un significato nascosto? E che questi bambini cercano disperatamente di comunicare con noi e che noi siamo sordi? È possibile che il mordere, ruotare, urlare, colpire, siano tutte parti di un codice che non abbiamo ancora decifrato? È possibile che il bambino autistico stia tentando di comunicare con noi e che noi non sappiamo rispondere?
Nel 1943 il neuropsichiatra infantile Leo Kanner, descrisse con la formula di “autismo infantile precoce” cinque principali caratteristiche:
– incapacità di mettersi in relazione e interagire con gli altri
– impossibilità a comunicare con gli altri attraverso il linguaggio
– ossessione nel mantenere l’uniformità e resistere ai cambiamenti
– il preoccuparsi di oggetti a preferenza degli uomini
– evidenza occasionale di un buon potenziale di intelligenza.
Con Kanner, l’autismo indica un insieme di sintomi per riferirsi a una entità nosografica di tipo congenito, a carico dell’affettività e a eziologia ignota. Successivamente, egli ricondusse le caratteristiche dello stato autistico all’isolamento estremo e all’avversione per i cambiamenti, con inizio entro i primi 2 anni di vita.
Poiché all’inizio non si conosceva nessuna causa fisica per il comportamento autistico, si accettò una prima spiegazione data da Freud riconducibile ad una rabbia interiore, sebbene ciò non portò a nessun successo nella cura e si dovettero ricercare altre spiegazioni.
Tra il ’50 e il ’60 furono scritti vari articoli per differenziare l’autismo dalla schizofrenia infantile precoce e dal ritardo mentale, poiché spesso le diagnosi si sovrapponevano.
Bender, invece, un esperto del settore, pensò che l’autismo fosse di origine organica, causato da una “encefalopatia di origine prenatale”, il che significa una mancanza diffusa di sviluppo cerebrale prima della nascita.
Rimland correlava le cause a una lesione alla formazione reticolare del peduncolo cerebrale, in bambini geneticamente predisposti, illustrando come i sintomi dell’autismo potessero risultare dalla difficoltà di dare un significato alle stimolazioni sensoriali in arrivo. Anche Schopler riconduceva le cause a fattori sensoriali e genetici.
Delacato invece, psicologo statunitense, non accettava le implicazioni genetiche delle posizioni di Rimland e Scholpler poiché se nell’autismo ci fosse stato un fattore di origine genetica, il suo schema dovrebbe essere riconoscibile da una generazione all’altra e la sua apparizione doveva seguire una regola, di generazione in generazione, ma invece non lo fa. Egli fu colpito dal fatto che i bambini autistici manifestassero comportamenti stereotipati e ripetitivi (ruotare oggetti, sfarfallare le mani, dondolarsi, ecc.), aspetto più estremo del problema, che li faceva sempre più rinchiudere in un mondo tutto loro e distaccare da quello reale ma al tempo stesso sembravano stranamente più soddisfatti. Potevano dunque questi bambini manifestare gravi problemi sensoriali e non riuscire a organizzare gli stimoli che giungevano al loro cervello dal mondo esterno per rispondere adeguatamente alle richieste? Una o più delle loro vie di entrata (vista, gusto, udito, odorato, tatto) era in qualche modo “difettosa”: il loro strano comportamento ripetitivo era il loro tentativo, attraverso il ripetersi degli stimoli, di normalizzare quella o quelle vie.
TROPPO,TROPPO POCO O RUMORE BIANCO?
Secondo Delacato l’autismo è un problema neurologico che risulta da una cerebrolesione lieve e diffusa: tale definizione fu diffusa in medicina nel 1967, oggi identificata con disordine della connettività – alterazione funzionale della sostanza bianca, riconoscendo negli autistici aree di alta o bassa densità connettiva. Il disturbo della connettività è tendenzialmente nelle vie discendenti inibitorie, per tale ragione Delacato parlò di disorganizzazione neurologica poiché, anche se è fatta salva l’anatomia del SNC, la qualità e la quantità delle connessioni in un soggetto con neurosviluppo atipico modificano la risposta motoria e comportamentale.
L’autismo si presenta come un problema senso-percettivo che determina il modo in cui il cervello incamera ed elabora le informazioni che riceve dall’ambiente, ovvero problemi con una o più vie dal mondo esterno al cervello: vista, udito, gusto, tatto, odorato.
Egli osservò che il comportamento ripetitivo che distoglieva l’attenzione del bambino poteva essere collocato in una o più delle cinque vie sensoriali. Pertanto, c’erano bambini che ricadevano in una delle tre seguenti categorie, in base ai loro atteggiamenti sensoriali:
1. Iper: un sistema sensoriale a innesco rapido che lasciava passare troppa parte del messaggio al cervello portando ad un sovraccarico del sistema
2. Ipo: un sistema sensoriale lento che lasciava passare una parte troppo piccola del messaggio al cervello
3. Rumore bianco: un sistema sensoriale che operava con così poca efficienza che la sua stessa attività creava una interferenza o rumore nel sistema.
Egli scoprì che la cura poteva essere mirata a normalizzare il canale attraverso una stimolazione sensoriale che doveva essere loro fornita in frequenza, intensità e durata. Quando ciò accadeva, il bambino autistico diminuiva o cessava i suoi comportamenti ripetitivi e poteva rivolgere la sua attenzione al nostro mondo ed entrare a farne parte.
SCOPRIAMO L’AUTISMO E GLI ATTEGGIAMENTI SENSORIALI
Nella prima parte dell’articolo abbiamo visto che i bambini autistici negli anni ’60 venivano considerati psicotici.
Delacato, invece, famoso neuroscienziato ed esperto di autismo, rifiutò da subito tale ipotesi diagnostica poiché per lui si trattava di un problema di neurosviluppo. Egli scoprì che alla base dell’autismo vi era una spiegazione neurologica, correlando le anomalie comportamentali ai disturbi senso- percettivo-motori. Quanto scritto nel DSM V e soprattutto quanto pubblicato dai neuroscienziati, ha confermato in pieno le sue intuizioni sull’autismo.
La teoria di Delacato afferma che:
– i bambini autistici manifestano disfunzioni percettive, ovvero problemi con una o più vie dal mondo esterno al cervello
– gli strani comportamenti ripetitivi del bambino autistico sono atteggiamenti sensoriali, che rappresentano i tentativi del bambino di normalizzare le vie sensoriali disfunzionali
– Il bambino cerca di “curare se stesso”, in una sola parola di autoregolarsi: è proprio questo tentativo di normalizzare le sue vie sensoriali che distoglie l’attenzione del bambino dalla realtà, con difficoltà di sopravvivenza nel mondo reale, ricco di stimoli sensoriali (propriocettivi, visivi, uditivi, tattili, olfattivi e gustativi, ecc)
– tale comportamento è il messaggio del bambino e bisogna osservarlo attentamente per capire quali sono le vie sensoriali disfunzionali e soprattutto se la via è iper, ipo o rumore bianco
– quando abbiamo individuato quali vie sensoriali sono disfunzionali, possiamo aiutare il bambino con una stimolazione sensoriale giusta attraverso quella via: in questo modo il canale si normalizza, il comportamento ripetitivo cessa e il bambino avrà la possibilità di “uscire dal suo mondo” e interagire con il mondo reale, apprendere e comunicare con le persone.
Ogni bambino autistico è un individuo a sé e di conseguenza ogni bambino può creare nuovi atteggiamenti sensoriali.
Una delle difficoltà che si incontrano nell’osservare gli atteggiamenti sensoriali dei bambini autistici è la nostra stessa funzione sensoriale: è importante guardare al di là della nostra normale funzione sensoriale mentre valutiamo il bambino e il suo comportamento.
Alcuni suggerimenti generali che possono aiutare a osservare e valutare i comportamenti:
– ogni volta che un bambino autistico entra nella stanza di terapia e scappa o si nasconde, possiamo concludere che egli scappa per proteggersi
– scegliere una stanza tranquilla senza rumori e osservare cosa attira l’attenzione del bambino e quali aree sensoriali racchiudono le sue anormalità, imparare ad ascoltare i suoi movimenti, i suoni e i rumori che produce con gli oggetti, cercare di non imporsi ma attendere che il b.no si avvicini ed essere il più amichevole possibile, parlargli con un tono basso di voce e naturalmente, senza essere loquaci.
Analizziamo in dettaglio i vari sistemi sensoriali e le loro relative manifestazioni in iper, ipo o rumore bianco.
1. TATTO
Il sistema tattile riceve e trasmette le informazioni provenienti dai recettori sensoriali situati nella nostra pelle. È attraverso il sistema tattile che riceviamo informazioni sul mondo che ci circonda quando lasciamo l’ambiente uterino e contribuisce al nostro sviluppo sociale ed emotivo.
Il sistema tattile inoltre svolge un’azione protettiva che ci allerta quando qualcosa è spiacevole o pericoloso.
Se osserviamo gli atteggiamenti del tatto, notiamo differenti reazioni del bambino alle variazioni di temperatura, al dolore e alla pressione: alcuni percepiscono tali informazioni tattili come spiacevoli o minacciose e reagiscono con una reazione di “lotta o fuga”, altri le avvertono molto poco; inoltre possiamo osservare la sensibilità propriocettiva attraverso la coordinazione dei suoi movimenti e l’equilibrio.
Nel valutare gli atteggiamenti del tatto, bisogna osservare l’uso delle mani (esaminatori tattili che usiamo più spesso) e qualsiasi attività ripetitiva che coinvolga la pelle e che possono variare dal mordere e colpire, al carezzare o solleticare.
a. BAMBINO IPER-TATTILE
Il bambino ipertattile è quello che ha reazioni negative e sproporzionate ad alcuni tipi di stimoli tattili percepiti in maniera neutra dalla maggior parte delle persone: rifiuta il contatto e, se viene toccato, reagisce lottando o scappando (preferisce toccare piuttosto che essere toccato), respinge anche il contatto con i vestiti (soprattutto ruvidi e troppo costrittivi o quelli con etichette interne). I problemi del vestire sono difficili da catalogare poiché, anche se sembrano il risultato di un tatto iper, potrebbero essere anche il risultato di un odorato iper. Inoltre il b.no evita alcuni cibi (è sensibile alla loro struttura in bocca), evita di camminare a piedi nudi (specialmente sull’erba o sulla sabbia), non ama le variazioni di temperatura e pressione. È iperattivo e distraibile. Sceglie sempre giocattoli morbidi o pelosi e in genere li usa per accarezzarsi il corpo nel tentativo di normalizzare le vie tattili. Manifesta disagio quando viene preso in braccio, non tollera l’acqua a meno che non sia alla temperatura del corpo o alcuni compiti quotidiani (fare la doccia, farsi tagliare i capelli, lavarsi il viso o i denti), presenta avversione nei confronti di alcuni materiali quali sabbia, pongo, colori a dita, reagisce negativamente al tocco leggero a livello di braccia, viso o gambe.
b. BAMBINO IPO-TATTILE
Il bambino ipotattile può mostrare scarsa o nessuna reazione al dolore, può venire ferito seriamente e non piangere. Può sorridere quando viene percosso, non si rende conto di essere toccato a meno che lo stimolo tattile diventa intenso, fa cadere oggetti o sbatte contro persone/mobili e non se ne accorge poiché è inconsapevole delle sensazioni del suo corpo. Si autoferisce, ha zone callose o con lividi come mani, braccia, ginocchia, gomiti, si morde le mani o altre parti del corpo, si colpisce, si mette in posizioni contorte, che sarebbero per noi dolorose, nel tentativo di autopercepirsi. Svolge attività ripetitive con il corpo (è importante osservare attentamente questi movimenti grossolani per essere sicuri di valutare anche gli aspetti visivi e uditivi). Si tocca continuamente anche le zone ferite del suo corpo senza permettere la loro guarigione.
c. TATTO- RUMORE BIANCO
È il bambino che gratta inesistenti pruriti sul suo corpo: spesso sembra grattare inesistenti punture di zanzara o di mosca, spesso rabbrividisce come se qualche oggetto che non vediamo li toccasse. È soggetto a “esplosioni tattili” che comportano il colpire e schiaffeggiare se stesso o altri: dopo tali esplosioni sembra tranquillo per un certo periodo dal punto di vista tattile, fino a quando si verifica un altro aumento.
2. ODORATO
L’odorato è per i bambini autistici la zona meno capita del comportamento e i problemi di questa zona sono considerati gli atteggiamenti più antisociali. Un tempo tale senso fu di primaria importanza nella nostra evoluzione ed era la via sensoriale principale.
a. IPER- ODORATO
Il bambino iperolfattivo o iperodorato ha un senso dell’olfatto eccessivamente sviluppato e questo comporta una serie di conseguenze negative sulla sua vita adattiva. Tutti abbiamo un odore che ignoriamo ma questo b.no non può farlo, è respinto da alcuni odori e attratto da altri e tale condizione ha notevoli ripercussioni sul suo comportamento. È un b.no che avverte gli odori a distanze molto maggiori rispetto a noi, vomita quando sente l’odore della sua urina o è talmente nauseato da questo odore che rifiuta di urinarie e defecare fino a quando non riesce più a trattenersi.
Un aspetto molto interessante è che questo è anche il bambino che lotta al seno, ovvero non riesce a sopportare l’odore e lotta per allontanarsene, mentre in genere è la capacità olfattiva che guida un neonato verso il capezzolo del seno.
È inoltre il bambino che lotta quando viene sollevato o preso in braccio poiché non tollera l’odore del caregiver che lo abbraccia; è anche selettivo nell’alimentazione e spesso non mangia: non sopporta cibi dagli odori forti e quando questi odori aumentano aumenta il suo comportamento di rifiuto. Di conseguenza vomita facilmente poiché non è inconsapevole della presenza degli odori che lo circonda.
b. IPO-ODORATO
Il bambino ipoodorato è quello che, cercando gli odori intensi, prova un grande piacere. Il comportamento più problematico è quando lo troviamo a giocare con le sue stesse feci o cosparge il muro o un oggetto con le stesse. Nelle feci egli trova l’odore di rifiuto più potente, più piacevole e comprensibile. È il bambino che con molta facilità bagna il letto o il pigiama e gioca con la sua stessa urina, annusa ogni oggetto che incontra interpretandone il marchio olfattivo e ogni persona nella stanza prima di fare qualunque altra cosa. Se osserviamo o annusiamo le sue mani, notiamo che sono sempre bagnate di saliva; inoltre è il bambino che mangia indiscriminatamente, anche cose non commestibili. Si rassicura annusando il suo stesso odore che, più è forte e più è felice. Gli piace stare in bagno e spesso è riluttante a far scorrere via con l’acqua le sue feci nel water, prova piacere nel sentire l’odore della gente.
c. ODORATO- RUMORE BIANCO
È il bambino che manifesta un odore costante nel suo sistema olfattivo. È come se avesse un odore interno che il suo naso riuscisse a percepire. Spesso posa una mano sulla bocca e il naso e soffia l’aria dall’una all’altro per sentire l’odore del suo alito, tende a cacciare piccoli oggetti dalle narici, in un tentativo di cambiare i meccanismi del suo odorato. Talvolta cerca gli odori esterni, altre volte li respinge e scappa via da essi. Diventa molto teso quando ha una congestione nasale o un raffreddore.
3. UDITO
Molti bambini con atteggiamenti uditivi sono semplicemente diagnosticati come sordi. È spesso difficile differenziare gli ipo dagli iper. Questo è il risultato dei tentativi del bambino iperuditivo di salvare se stesso nel nostro mondo rumoroso, tagliando fuori ogni rumore. È come se “spegnesse” il suo sistema uditivo risultando sordo.
Ricordiamo che l’organo dell’udito è l’orecchio. L’orecchio interno e l’equilibrio sono in stretta relazione: udito ed equilibrio devono quindi essere osservati insieme.
Generalmente, i movimenti rotatori del corpo e qualunque attività che faccia venire il capogiro, se non comprende gli occhi coinvolge l’udito. I bambini con problemi di “input” uditivo sono i più difficili da trattare dal punto di vista comportamentale e sono complessi da capire e da controllare.
Le stanze da bagno sono spesso di aiuto per diagnosticare gli atteggiamenti uditivi, poiché il suono rimbalza e riecheggia rapidamente attraverso la stanza. Possiamo dire che il b.no che ama giocare nella stanza da bagno probabilmente è ipoauditivo, mentre quello che si oppone quando dovrebbe andare nella stanza da bagno è iper.
Nel valutare gli atteggiamenti uditivi bisogna ricercare ogni attività che produca dei suoni. Se ascoltiamo il bambino chiudendo gli occhi, i suoni andranno da quelli vocali allo schioccare delle labbra, a battere leggermente sulle orecchie, allo sbattere assieme degli oggetti incessantemente.
Non è consigliabile usare la musica per valutare la funzionalità uditiva poiché essa cambia l’atteggiamento di ascolto dei bambini con problemi uditivi. Questi bambini imparano spesso com’è un oggetto palpandolo, battono leggermente sull’oggetto con un dito e ascoltano le diversità dei suoni su parti diverse dell’oggetto. Quando il palpare non è sufficiente, questi bambini romperanno l’oggetto ascoltando attentamente i suoni che produce quando viene distrutto.
a. IPER-UDITO
Il comportamento del bambino iperuditivo è in genere quello di evitare o respingere: si allontanerà dal rumore e dai suoni o si tapperà le orecchie con le mani, respingendo completamente il suono. In quest’ultima situazione egli sarà giudicato e sembrerà essere totalmente sordo: viene ferito dai suoni e poiché non può fermarli anche se si allontana o si chiude le orecchie, li spegne nel suo cervello. Questa sordità transitoria sparisce non appena comincia a produrre suoni ripetitivi che ascolterà con piacere.
Bisogna ricordare che il bambino iperuditivo sente molti suoni che noi, con un udito normale, non avvertiamo. Anche dormire diventa per lui un problema, ha un sonno molto leggero poiché avverte suoni che noi riusciamo ad escludere dalla nostra consapevolezza. Ad esempio, può sentire il rumore di apparecchi elettrici, televisivi, rumori provenienti dai tubi dell’acqua, dal respiro o dal vento. Ha paura degli animali poiché producono rumori in momenti imprevedibili, ha timore del taglio dei capelli (è spaventato non solo dal taglio delle forbici ma anche dal rumore del rasoio vicino all’orecchio). Anche pulirgli e lavargli le orecchie rappresenta per lui una tortura. Inoltre è spaventato dalla folla, dalle gallerie, dal traffico, dalle sirene delle ambulanze, dagli acquazzoni forti, dai tuoni, essendo rumori che si verificano improvvisamente e sono troppo forti per essere facilmente assorbiti.
Il bambino iperuditivo quando non riesce a controllare il dolore e la paura del rumore nel suo ambiente, cerca di allontanarsi dalla sorgente del rumore: può nascondersi sotto una coperta, lasciare la stanza o addirittura fuggire di casa. Dobbiamo fare attenzione perché ad esempio il nascondersi sotto una coperta può essere la reazione di un b.no iperuditivo o ipervisivo; pertanto bisogna osservare che cosa fa scattare tale reazione, se il suono o la vista.
b. IPO-UDITO
È il bambino per cui il mondo è troppo quieto, è quello che grida, che sbatte violentemente. Una parte insufficiente del messaggio di suoni del mondo raggiunge il suo cervello e per tale ragione egli cerca altri suoni che abbiano una maggiore durata e frequenza. Egli crea rumori forti e ritmici e si muove verso di loro, appoggia l’orecchio a superfici vibranti e rumorose. Ama i suoni violenti, i rumori del traffico, può rimanere ore ad ascoltare una lavatrice, un frullatore o un aspirapolvere, gli piace strappare la carta (soprattutto rigida e non morbida); adora sbattere le porte e sembra distruttivo nella ricerca di suoni, come se frantumasse le cose per vedere che suono c’è dentro. Ama i giocattoli che fanno rumore o che cigolano: se il giocattolo è silenzioso, il problema generalmente è visivo, mentre se è rumoroso, molto probabilmente è uditivo.
c. UDITO- RUMORE BIANCO
È il bambino che sembra preoccuparsi dei suoi rumori interni, che ascolta il battito del suo cuore dopo aver corso, che ascolta il suo apparato digerente dopo aver mangiato o che respira in fretta per la bocca e ascolta il suo respiro. Una nota interessante è che questo è anche il b.no che spesso si dondola (soprattutto la testa) e poi si ferma, come per ascoltare la differenza del rumore nella sua testa. Può adottare posizioni gravitazionali strane: ad es. sembra ascoltare se stesso attaccato ad una sedia con la testa in giù; canticchia spesso e fa un rumore basso continuo e lo ascolta.
4. GUSTO
Il principale organo del gusto è la lingua, che possiede circa dieci mila papille gustative. La punta della lingua è sensibile soprattutto al salato e al dolce, i lati della lingua all’acido e la parte posteriore ai sapori amari.
È interessante sapere che i bambini iper nel gusto tendono ad usare la punta della lingua per assaggiare, controllano cibi e oggetti dolci o salati. I bambini ipo nel gusto usano la parte posteriore e quelle laterali della lingua, controllano l’acido e l’amaro. I bambini con rumore bianco nel loro sistema gustativo, tendono invece a succhiare con la parte posteriore e quelle laterali della lingua, controllando i gusti acido e amaro.
La lingua è anche molto sensibile dal punto di vista del tatto: è talvolta difficile separarne la funzione gustativa e quella tattile.
a. IPER- GUSTO
Il bambino iper nel gusto si allontana da gusti molto forti, vomita spesso, mangia molto poco e solo cibi poco saporiti. Pertanto, manifesta precoci problemi di alimentazione poiché la sua tolleranza alle variazioni di gusto è molto limitata.
b. IPO-GUSTO
Il bambino ipo nel gusto mangia qualsiasi cosa (anche non commestibile o di gusto repellente), non discrimina il cibo. Può mangiare e bere sostanze estremamente dannose come la benzina e sostanze velenose come la vernice. È il bambino che subisce spesso lavande gastriche per la sua mancanza di discriminazione su ciò che mangia o beve.
c. GUSTO- RUMORE BIANCO
È il bambino che ha sempre un “gusto” in bocca. Se si osserva questo bambino possiamo notare che si comporta come se si succhiasse la lingua o le gengive per avere da queste un gusto. Spesso rigurgita il cibo ingerito o lo rimastica e ingerisce. È spesso indifferente al cibo, permette agli altri di alimentarlo ma raramente lo fa da solo. Se osserviamo la sua lingua notiamo che è grossa e larga, come conseguenza del gustare la propria saliva.
5. VISTA
Come valutiamo gli atteggiamenti visivi del bambino? Osservando qualunque cosa che contenga un movimento del corpo, come il dondolarsi, il girare, il ruotare o qualsiasi movimento che si verifichi davanti agli occhi. La maggior parte dei movimenti ritmici di oggetti entro il campo visivo, purché non sia implicato rumore, sono indicatori visivi (automobili, orologi, dischi che girano, ecc.).
a. IPER-VISIONE
È il bambino che guarda costantemente piccole particelle di polvere o oggetti nell’ambiente circostante. Può passare ore a togliere peluzzi da un tappeto o dai suoi vestiti, può rimanere per ore ad osservare un granellino di polvere o una goccia di saliva tra le dita, un capello, compiere movimenti improvvisi ma controllati. Tali movimenti possono essere laterali, permettendo al bambino di vedere come se muovesse gli occhi da destra a sinistra oppure in avanti e indietro, consentendo al b.no di avvicinarsi o allontanarsi dall’oggetto. Questo bambino è attratto da orologi, ruote, dischi che ruotano, trottole, quindi da oggetti che osservati a lungo e intensamente, provocano illusioni ottiche. Ha un’ottima memoria visiva ma non ama gli specchi né vedersi riflesso in uno specchio, nell’acqua o in fotografia. In genere, ha paura del buio, di fasci improvvisi di luce, dei lampi e non ama la luce brillante del sole.
b. IPO-VISIONE
Una delle caratteristiche del bambino ipovisivo è il dondolarsi: si dondola avanti e indietro, spostando l’oggetto osservato da vicino a lontano. Inoltre è attratto da fasci di luce come il sole e punti di luce e può passare molto tempo ad osservarli, ha paura dell’altezza, delle scale, delle gallerie buie, della velocità (le sue capacità visive non riescono a fronteggiare la velocità e la profondità). Può andare avanti e indietro da una superficie colorata ad un’altra, come la linea di incontro di due tappeti di diverso colore, nel tentativo di normalizzare il suo sistema visivo.
Un comportamento complesso da comprendere è il lento camminare attorno ad un oggetto, la sua attenta osservazione mentre gira attorno: questo potrebbe essere un tentativo di fissare il contorno dell’oggetto per capire la sua posizione nello spazio.
Bisogna osservare da vicino come ruota gli oggetti ad esempio le matite: se è fatto davanti agli occhi è un atteggiamento visivo. È affascinato dagli specchi o oggetti a superficie riflettente, dal vento che fa volare le foglie; può soffiare pezzettini di carta o granelli di polvere per vederli muoversi.
Un’altra sua caratteristica è l’intrecciare le dita o il giocare con le mani, attività che compie sempre entro il campo visivo. Lancia oggetti leggeri e li osserva, al contrario degli ipoauditivi che in genere lanciano quelli pesanti.
c. VISIONE-RUMORE BIANCO
È il bambino che manifesta spesso le pupille dilatate, che guarda attraverso la gente e le cose, che si comporta come se osservasse qualcosa con molta attenzione, ma qualcosa che è dentro il suo bulbo oculare. Vede come se i suoi occhi non fossero rivolti verso il mondo esterno ma dentro se stesso.
È il bambino che si tocca, si sfrega, si colpisce spesso gli occhi per far apparire lampi interni di luce nel suo sistema visivo. Anche se nessuno dei bambini con atteggiamenti visivi mostra rapidamente e a lungo un contatto visivo (guardandovi dritto negli occhi), a questo bambino riesce impossibile, anche se è obbligato a farlo. Si comporta come una persona realmente cieca: la sua attenzione è rivolta verso un mondo che non c’è.
In conclusione, dopo questa lunga descrizione dei vari sistemi sensoriali, osservando il bambino autistico dobbiamo chiederci quale o quali canali sono compromessi? Iper, ipo o rumore bianco?
Questi esempi specifici vogliono essere una guida per le vostre osservazioni e valutazioni, sempre ricordandovi che ogni bambino è un individuo a parte che crea nuovi atteggiamenti sensoriali (che possono non emergere tra quelli appena descritti!). Se il vostro bambino manifesta atteggiamenti particolari in più di un canale sensoriale, cercate di capire quale via è disfunzionale e partire a lavorare da quella stessa via, in cui il bambino manifesterà il maggior numero di atteggiamenti.
CONCENTRIAMOCI SULLA CAUSA e NON SUL SINTOMO: TERAPIA SENSORI-MOTORIA
L’obiettivo della terapia sensori-motoria è di eliminare o ridurre gli atteggiamenti sensoriali in modo che il bambino possa essere accettato da coloro che lo circondano ed essere meglio integrato nella società sia dal punto di vista comportamentale che educativo, e in modo che possa rivolgere la sua attenzione verso il nostro mondo e le sensazioni a cui noi vogliamo che egli presti attenzione.
Anziché focalizzarci sull’estinzione di certi atteggiamenti, se comprendiamo il motivo dei comportamenti del bambino possiamo aiutarlo meglio ad autoregolarsi, ad esempio variando l’ambiente e adattandolo in base alle sue necessità, diminuendo il suo disagio sensoriale.
Per quanto possibile, possiamo alterare le funzioni della terminazione sensoriale da cui questi atteggiamenti hanno avuto origine.
Possiamo inoltre aiutare il bambino a normalizzare la via o le vie sensoriali anormali.
Elenchiamo di seguito alcuni suggerimenti che possono fungere da guida, sempre tenendo in considerazione che ogni bambino è diverso dagli altri e può trarre benefici anche da altri tipi di approcci/tecniche. Tuttavia, potete utilizzarli come guida, modificandoli e adattandoli in base al bambino che avete di fronte.
A.TATTO
Ricordiamo che le modalità del tatto sono 4: temperatura, dolore, pressione, propriocezione. Inoltre, se la pelle è l’organo terminale del tatto, bocca, lingua e denti sono sensibili in questo campo. Tutto il corpo è sensibile per quel che riguarda il tatto: per essere percepiti, l’oggetto o la persona devono venire in contatto col corpo del bambino, tranne nell’area della temperatura.
IPER-TATTO
Questo bambino è molto influenzato dal tatto, che monopolizza i suoi pensieri ed è l’origine delle sue paure.
Possiamo eliminare i vestiti ruvidi, pesanti, stretti e fargli indossare abiti che preferisce, abbracciarlo in modo gentile (poiché non ama una forte pressione sul suo corpo). Questo b.no ha molta paura del dolore, per cui anche un lieve dolore come una ferita o una ciglia nell’occhio può renderlo aggressivo o nervoso.
Può essere difficile fargli il bagno e può urlare quando gli vengono tagliate le unghia dei piedi o delle mani. Dobbiamo ricordarci che per lui è un dolore!
Tenderà ad essere caldo al tatto e a sudare con facilità: per tale ragione è consigliabile mantenere bassa la temperatura a casa e assicurarsi che non abbia indumenti di lana. Inoltre è ipersensibile al freddo, quindi bisogna mantenere la temperatura il più costante possibile.
Se assume posizioni anomale del corpo quando è seduto o se intreccia le dita, all’inizio della terapia possiamo lasciarglielo fare poiché sono sensazioni propriocettive che lo tranquillizzano.
Successivamente possiamo inserire gradualmente attività propriocettive più variate, e non opprimerlo con sensazioni tattili per lui spiacevoli. È un bambino molto sensibile al solletico: anche un soffio d’aria potrebbe modificare negativamente il suo comportamento.
Bisogna osservare quali atteggiamenti tattili gli provocano piacere e fargli ciò che lui fa a se stesso: ad es. se si accarezza una guancia, possiamo accarezzargli l’altra guancia, lentamente e, se lo tollera, passiamo ad un altro atteggiamento tattile che gli piace. Pertanto, il primo passo è quello di creare nel bambino un maggior grado di tolleranza alla stimolazione tattile proveniente dall’esterno e controllata da altre persone. Successivamente, si può stimolare lentamente il suo volto, con un tocco molto leggero delle dita e arrivare fino alle orecchie con una leggera azione di massaggio.
Inizialmente il b.no ipertattile potrebbe arrabbiarsi e respingere l’azione e, appena comincerà ad accettare questo massaggio leggero, possiamo pronunciare ogni parte del suo volto che viene toccata. Passare poi dal volto al corpo, alle braccia e alle mani. Attenzione: all’inizio procedere con il palmo delle mani e quando comincerà a sopportarlo, passare ad una carezza leggera con le punta delle dita, pronunciando sempre ciò che tocchiamo. Se non tollera tali azioni, fermiamoci e poi riprendiamo.
IPO-TATTO
Questo bambino necessita di tutta la stimolazione tattile possibile, di variazioni di temperatura nel suo ambiente quotidiano e di numerose esperienze propriocettive. Ama la pressione e gli abbracci molto forti.
È consigliabile farlo muovere, proporre attività che implicano la coordinazione di braccia e gambe, correre, saltare, rotolare, strisciare, lanciare e afferrare una palla, ecc. Se manifesta movimenti ritmici del corpo cerchiamo di esagerarli e aumentarli.
Dobbiamo spesso spazzolare, stuzzicare, pizzicare, sfregare la sua pelle: in questo modo aiutiamo il messaggio a passare dalla pelle al cervello aumentando FREQUENZA, INTENSITÀ e DURATA dell’applicazione dello stimolo. Inoltre bisogna variare gli input tattili il più possibile, soprattutto in quelle zone che il b.no ferisce, colpisce, tormenta e che necessitano di una maggiore quantità di stimoli.
Cambiargli spesso la temperatura dell’acqua, soprattutto immergendo braccia e mano del bimbo nella stessa, massaggiando e pizzicando la sua pelle ma prestando attenzione a non fargli male poiché ha una percezione del dolore inferiore al normale. In seguito asciughiamo mano e braccio con un asciugamano ruvido. A molti di questi bambini piace il vibromassaggio su tutto il corpo.
TATTO- RUMORE BIANCO
Il bambino ha bisogno di sperimentare molte sensazioni tattili provenienti dall’esterno del suo corpo e controllati da persone diverse da lui. Ogni volta che gli viene fornito uno stimolo tattile, bisogna indicargli la sua origine e dobbiamo spiegargli cosa gli stiamo facendo prima e durante la stimolazione, sempre!. Ad esempio, dobbiamo dirgli “sto per stringerti e poi sollevarti”; mentre si esegue questa azione, dobbiamo continuare a dirgli ciò che stiamo mettendo in atto. Quando comincerà a capire le stimolazioni provenienti dall’esterno in opposizione a quelle interne, possiamo fornirgli una grande varietà di esperienze. Ha bisogno prima di riuscire a discriminare due diversi input tattili. In totale, avrà bisogno di esperienze tattili provenienti dall’esterno nel modo più costante possibile nell’area della temperatura, pressione, dolore e della propriocettività. Più lo stimoleremo dal lato del tatto e meno si concentrerà sulle sue sensazioni tattili interne.
Quando aumenterà la sua tolleranza allo stimolo tattile, possiamo cambiare il ritmo dello stesso, rendendolo sempre diverso e ripetendolo costantemente.
B. ODORATO
Tutti noi, che abbiamo normali capacità olfattive, incontriamo grandi difficoltà nel capire i problemi che coinvolgono l’olfatto e dobbiamo considerare che ogni persona è circondata da un odore e che i nostri odori cambiano continuamente.
IPER-OLFATTO
È importante avvicinarci a questi bambini pian piano, tenendo presente che i nostri corpi emanano un forte odore. Con questi bambini non dobbiamo coprire gli odori del corpo con altri, né lavare i vestiti con saponi profumati. Si consiglia di limitare al minimo gli odori domestici, soprattutto quelli forti di cucina e di cibi; il cibo deve essere leggero e inodore per questi bambini iperolfattivi. Quando l’ambiente olfattivo diventerà più tollerabile, possiamo fornirgli odori deboli e leggeri, dicendogli sempre come sarà l’odore e avvicinandoglielo sempre di più, ma senza metterglielo sotto il naso (può sentire odori a distanze molto maggiori delle nostre). Quando sopporterà odori leggeri e lontani, possiamo introdurre odori umani: facciamo avvicinare le persone a lui, facciamogliele annusare. Ciò che bisogna fare è dunque insegnare a questi bambini a vivere con gli odori e a sopportare odori che non possono controllare, avvicinandoli il più possibile a un normale ambiente olfattivo.
IPO-OLFATTO
Questo è il bambino che necessita di un ambiente con odori intensi, come quelli domestici, odori di vestiti o di rifiuti. Bisogna invitarlo ad annusare cibi aromatici, sempre spiegando che tipo di odore è. Porre l’oggetto da annusare sotto il naso del bambino e, quando migliorerà la sua capacità olfattiva, fornirgli odori meno intensi e metterli più lontano dal suo naso. Successivamente cominciare la discriminazione tra due odori molto forti e diversi e scoraggiare il suo annusare da vicino persone e oggetti. L’obiettivo è quello di aumentare la distanza a cui annusa gli oggetti, imparare ad aspettare gli odori e a non andarli a cercare.
OLFATTO-RUMORE BIANCO
Lo scopo è far si che il bambino reagisca agli odori provenienti dall’esterno, creando un ambiente inodore. Cambiare ogni giorno gli odori da mettere sul corpo e sui vestiti del bambino. Ogni mattina bisogna specificare che tipo di odore gli mettiamo e quando migliorerà, potremmo variare con odori non troppo specifici e distinti e meno intensi. Man mano possiamo introdurre altri odori, oltre a “quello del giorno”, per aumentare la sua capacità discriminativa e facendoglieli riconoscere anche ad occhi chiusi.
C. UDITO
I bambini con problemi uditivi sono prigionieri del loro ambiente. Dobbiamo fare attenzione agli ambienti poiché alcuni assorbono il suono mentre altri lo riflettono. Lo scopo è quello di far capire loro da dove proviene il suono e ascoltare i suoni controllati da altri.
IPER-UDITO
Questo bambino cancella ogni suono che non sia creato da lui, è come se fosse completamente sordo al suono controllato da altri (risulta anche sordo ad ogni test). Il consiglio è quello di allontanarlo da ambienti affollati, rumorosi, non gridare mai con lui, piuttosto bisbigliare quando vogliamo comunicare con lui: se insistiamo e utilizziamo suoni non minacciosi o forti, pian piano il bambino comincerà a rispondere ai nostri suoni, a far entrare il suono, perdendo anche quel grigiore sul volto che lo caratterizza. Non dobbiamo costringerlo a stare in cucina o in bagno, essendo posti che non assorbono il suono anzi lo amplificano; piuttosto circondarlo di un ambiente che assorbe il suono (tappeti, tappezzerie). Assicuriamoci che dorma in una parte tranquilla della casa poiché ogni suono potrebbe interferire con il suo sonno (si può utilizzare una musica dolce di sottofondo finché non dorme). Può scappare quando non riesce più a “nascondersi” dai suoni che lo circondano e lo feriscono, come ad esempio quando è in ambienti rumorosi o con molte persone: in questo caso dobbiamo cercarlo con molto silenzio (spesso si nasconde sotto una coperta o una tenda per proteggere il suo orecchio troppo sensibile). Per diminuire il suono in arrivo e la sua intensità, possiamo fargli indossare dei tappa orecchie o delle cuffie, soprattutto quando l’ambiente sonoro è per lui troppo difficile da tollerare.
IPO-UDITO
È il bambino che richiede molta stimolazione uditiva, ma non caotica. Il suono deve essere netto, riconoscibile e presentato singolarmente, non insieme ad altri suoni. Bisogna inserirlo in un ambiente che rifletta il suono, come ad esempio cucina e bagno (evitare tappeti, tappezzerie e rivestimenti acustici). Prediligere giocattoli rumorosi e un tono deciso e forte di voce quando gli parliamo: cerchiamo di fare in modo che egli ascolti le nostre parole senza forzarlo, e che riesca a capire, localizzare e immagazzinare i suoni. Questo bambino adora i rumori del traffico, della folla, il rumore della risacca sulla spiaggia, ecc. poiché sono zone che aumentano l’intensità del suono. Adora anche gli animali, soprattutto i cani, arrivando spesso a far loro del male per sentirli abbaiare. Ogni giorno dovrebbe essere messo in un posto dove egli possa sbattere oggetti, gridare, dunque fare suoni ripetitivi e forti.
UDITO-RUMORE BIANCO
Non bisogna consentire a questo bambino di avere troppo tempo per stare seduto e ascoltare se stesso, tenendolo impegnato con ogni tipo di attività in modo da distrarlo dai suoi suoni interni. Quando c’è il temporale, diventerà più agitato poiché le variazioni nella pressione atmosferica sembrano provocare cambiamenti nei suoi rumori interni. Ama i gatti e adora ascoltare il loro rumore interno. Possiamo sollecitare strane posizioni di equilibrio, come stare sul pavimento, in bilico sulla testa, dondolarsi con gli occhi chiusi o correre, attività che modificano i suoi suoni interni permettendo al bambino di discriminarli. Un altro obiettivo è quello di aiutarlo a distinguere tra suoni interni ed esterni: possiamo utilizzare giocattoli rumorosi e fargli capire da dove proviene il suono in ogni occasione, oppure fargli sentire oggetti che producono suoni come lavatrici, pianoforti, facendogli apprendere le vibrazioni del suono attraverso il tatto.
Facciamo attenzione a eliminare i rumori di fondo, come potrebbe essere un condizionatore di aria. Possiamo utilizzare uno stetoscopio in modo da invitarlo ad ascoltare il battito del suo cuore, la sua digestione, la circolazione del sangue e dobbiamo scoraggiare i suoni costanti che egli produce. Eseguire vari giochi sonori che hanno lo scopo di fargli capire che si tratta di rumori esterni che si dovrebbero sentire, assicurandoci che egli ci osservi mentre stiamo producendo il suono. Ricordiamoci che la ripetizione è fondamentale per aiutare il bambino.
D. GUSTO
Questi bambini manifestano problemi di alimentazione: gli iper-gustativi possono mettere in pericolo la loro stessa salute poiché non tollerano l’odore dei cibi, gli ipo tendono a mangiare qualunque cosa e sono molto pericolosi per se stessi: non si dovrebbero lasciare in giro per casa sostanze o liquidi pericolosi e bisognerebbe sorvegliarli spesso. Ricordiamo che la punta della lingua è sensibile soprattutto al dolce e salato, i lati all’acido e la parte posteriore all’amaro.
IPER-GUSTO
Sono i bambini che in genere hanno poco appetito, vomiteranno spesso soprattutto se diamo loro cibo saporito e tendono ad usare la punta della lingua per i gusti salato e dolce. Sono indicati cibi leggeri senza spezie e non bisogna utilizzare bibite gassate né acido e amaro nei loro alimenti fino a quando il loro sistema gustativo non si è normalizzato. Quando li alimentiamo, bisogna mischiare un cibo nuovo con uno familiare: dobbiamo mettere qualche briciola di cibo nuovo e leggero sul palato, dietro gli incisivi e sulla punta, dicendogli sempre che cibo è. Quando imparerà a tollerare questo con i cibi poco saporiti, possiamo procedere con quelli dolci e poi salati, arrivando alla fine all’acido e all’amaro.
IPO-GUSTO
Si consiglia di eliminare tutte le sostanze velenose e i saponi molto forti poiché sono b.ni che non discriminano i gusti e possono mangiare ogni cosa che trovano. Dobbiamo quindi insegnare loro a discriminare i gusti. È stato scoperto che è più semplice con questi bambini far assaggiare loro del cibo con la parte posteriore della lingua, usando stimoli amari in forma liquida e dicendo sempre di cosa si tratta. Successivamente si passerà ai gusti acidi in forma liquida, poi a quelli salati e infine ai sapori dolci, sempre sulla punta della lingua. Quando avranno imparato a conoscere i sapori, possiamo iniziare a mescolare un giorno i gusti dolci, un altro giorno gusti amari, un giorno quelli acidi e l’altro giorno gusti salati, fino a mescolare i gusti all’interno delle esperienze di uno stesso giorno.
GUSTO- RUMORE BIANCO
È il bambino che ha sempre un gusto in bocca, che distoglie la sua attenzione verso l’ambiente esterno. Spesso se osserviamo la sua lingua vediamo che è grossa, poiché gusta la sua stessa saliva e la succhia. Bisogna scoraggiare il più possibile il suo rigurgitare e rimasticare il cibo, massaggiare la lingua e quando si lava i denti invitarlo a spazzolarla. Quando il b.no sarà pronto possiamo cominciare a superare il “rumore bianco”: mettiamo un cubetto di zucchero nello spazio tra i denti e la guancia, cercando di non farlo masticare dal bambino, e in modo che quando si scioglierà, il suo sapore filtrerà verso la lingua. Bisogna farlo con tutti i quattro gusti fondamentali, iniziando dal sapore che il b.no tollera meglio e dicendogli che gusto è prima di metterglielo in bocca. Poi possiamo cominciare a insegnargli a differenziare i gusti presentandoglieli e pronunciandoli; partendo da quelli dolci e salati (iniziando con la punta della lingua), li introduciamo nei suoi alimenti, assicurandoci che poi mastichi il cibo (non deve inghiottirlo senza masticarlo perché in questo modo non lo gusterà e poi potrebbe rigurgitarlo e rimasticarlo).
E. VISTA
Dobbiamo osservare tutti i movimenti in cui sono coinvolti gli occhi, quando valutiamo un bambino con atteggiamenti visivi: un movimento globale del corpo, di braccia e gambe nel campo visivo, il guardare oggetti in movimento come treni, oggetti che ruotano, il salto e il dondolamento, la rotazione, oppure possiamo notare tutti gli oggetti che questo bambino manipola ritmicamente davanti i suoi occhi.
IPER-VISIONE
È il bambino che necessita di meno stimolazione visiva possibile e che si comporta meglio in un ambiente con pochi stimoli visivi (luci non troppo forti e brillanti ma indirette) e senza specchi (in modo da non poter decomporre la luce o giocare con essa). Si consiglia di portarlo fuori la sera quando il sole è tramontato e la luce non è forte e di fargli indossare occhiali da sole quando invece deve stare fuori. Cerchiamo di controllare noi il suo movimento oculare: possiamo muovere una torcia attorno alla stanza, sollecitando il bambino a seguire la luce con gli occhi e scoraggiando ogni attività visiva controllata da lui. Proponiamo giochi che richiedono una buona abilità visuo-percettiva come puzzle e ricalchi, aiutandolo se all’inizio trova qualche difficoltà. Non incoraggiamo il bambino a stare troppo tempo con uno stesso tipo di gioco. Possiamo insegnargli a leggere poiché riesce molto bene e presto in questa abilità, oltre a possedere una eccellente memoria visiva (può osservare uno schema visivo complesso e ricordarlo nei minimi dettagli).
IPO-VISIONE
È il bambino che necessita di una grande quantità di luce solare, di luci brillanti e di stimolazione visiva. Sono molti utili i contrasti di luce e buio come la nettezza delle ombre. L’illuminazione deve essere diretta e non schermata, bisogna fargli passare molto tempo all’aperto e incoraggiarlo a sentire col tatto ogni cosa che vede; mostrargli luci a colori diverse e ombre, e come cambiano le ombre quando un oggetto viene spostato in relazione alla sorgente di luce. Aiutarlo ad imparare come sono i contorni delle persone e delle cose, come cambiano in base alla luce, toccandoli e osservandoli attentamente. Il movimento rappresenta sempre un problema per questo bambino poiché complica ancora di più il suo mondo a contorni indistinti. Quando trattiamo il bambino ipo-visivo dobbiamo assicurarci che guardi sempre un oggetto in linea retta, al centro del suo campo visivo e non lateralmente.
VISIONE-RUMORE BIANCO
Gli organi visivi di questo bambino operano come se fossero rivolti all’interno. Il nostro compito è quindi di aiutarlo a vedere verso il mondo esterno: non lasciargli toccare, colpire gli occhi poiché con queste attività il b.no si crea stimoli dall’interno, come lampi e giochi di luce direttamente nel cervello. Giocare insieme a lui con un pannello di luce che noi controlliamo, e che accendiamo e spegniamo alternativamente. Non dobbiamo forzare un contatto visivo ma proporre giocattoli luminosi in una stanza in penombra, in modo da attirare la sua attenzione visiva (dobbiamo mostrargli la sorgente di luce senza fargliela toccare). È molto utile usare uno specchio illuminato per aiutarlo a vedere cosa c’è al di fuori del suo campo visivo, e quindi rivolgere l’attenzione del bambino su qualcosa controllata dall’esterno e non da lui stesso. Inoltre, mente si osserva allo specchio, possiamo tracciare su questo con un dito il contorno del suo corpo, indicando man mano le diverse parti del suo corpo e facendogliele indicare in seguito su di noi. Possiamo incitare il movimento, come sollecitarlo a mettersi e camminare carponi, muovere le braccia lentamente mentre si guarda allo specchio, assicurandoci sempre che si muova con armonia e non a scatti. Scoraggiare il suo passatempo di “guardare dentro di sé” e cerchiamo di utilizzare alternative affinché il bambino possa guardare realmente ciò che lo circonda e prestarvi attenzione.
—☆—- Questi suggerimenti rappresentano una guida, poiché ogni bambino è diverso dagli altri. Pertanto, se conosciamo la causa e riusciamo a capire quale sia il sistema sensoriale “che non funziona”, possiamo generalizzare e improvvisare, al fine di ridurre gli atteggiamenti ritmici del bambino che lo allontanano dal mondo reale. Dobbiamo ricordarci che egli sta cercando di normalizzare da solo la via o le vie sensoriali abnormi, dunque di autoregolarsi e noi dobbiamo aiutarlo a liberarsi dai sintomi del suo comportamento disfunzionale ——☆——–
Dott.ssa Francesca Tabellione
Dott.ssa Erika D’Antonio
Bibliografia: “Alla Scoperta del Bambino Autistico” (Carl Delacato)
/wp:tadv/classic-paragraph